Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 11/15/23 in tutte le aree
-
Bellissimi i vedo riassuntivi della giornata di Milano Numismtica, che lasciono un segno impresso anche su internet, ma per chi era presente il ricodo di questa giornata rimarra indelebile, una sala gremita senza una sedia libera, interventi autorevoli e di giovani promesse, youtuber giovanissimi e tanti appassionati di ogni età. Non si potrebbe chiedere di più da un evento numismatico. 👍👍👍👍4 punti
-
Ottima recensione su Milano Numismatica su Cronaca Numismatica che ringraziamo con l’occasione https://www.cronacanumismatica.com/milano-numismatica-2023-un-successo-che-guarda-al-futuro/?fbclid=IwAR2Kv4c9iWNZUAqvkBDbE9NLJ2tl4rUr8ymsI1nbcTqiIhtFdpCxgxIUClg_aem_AfrWBrCRVWSl8KuBackIJU1ktxYEM7p4C5PsvDkTHol1gAEMRWtbkKZgHYsrgZP3pYU3 punti
-
Nuovo esemplare entrato in collezione : Carlo Emanuele III (1730-1773) - Soldo 1734 - MIR 9393 punti
-
All’estero sono collezionate tantissimo e pagate bene… in Italia invece c’è questa discriminazione un po’ fuori luogo…. Sono state fatte nello stesso periodo e dalle stesse popolazioni, quindi hanno dignità collezionistica3 punti
-
Ciao, oggi con particolare piacere condivido il mio ultimo arrivo che è il decimo sesterzio, ed il primo di un'Augusta, ad entrare in collezione 🙂. Si tratta di un sesterzio di Lucilla (164-182 d.C) recante sul rovescio la personificazione della dea Vesta stante, con simpulum nella mano destra, palladium a sinistra ed altare ai suoi piedi, coniato a Roma. Era la dea del focolare domestico molto venerata sia in privato ma soprattutto in pubblico nei templi a lei dedicati dove le Vestali, sacerdotesse scelte per tale scopo, avevano come compito specifico quello di tenere sempre acceso il sacro fuoco a lei attribuito. Lucilla, figlia dell'imperatore Marco Aurelio e dell'Augusta Faustina Minore, fu data in sposa poco più che fanciulla a Lucio Vero "adottato" come Marco Aurelio da Antonino Pio e designati come suoi successori. Fu il primo caso di due imperatori co-regnanti sul trono di Roma. Era una donna dal carattere forte, con buona cultura ( con un padre come Marco Aurelio, l'imperatore filosofo) ed anche discrete capacità politiche. Alla morte del marito durante una campagna militare ( per una malattia improvvisa, forse la peste antonina o di Galieno colui che all'epoca la descrisse. Dai sintomi descritti si poteva trattare di vaiolo o anche di morbillo propagotosi in tutto l'impero durante e dopo la guerra contro i Parti) fu costretta dal padre, dopo pochi mesi, a sposare un cittadino romano di origine siriana Tiberio Claudio Pompeiano Quintiniano di trent'anni più anziano ( lei e la madre Faustina erano contrarie, ma così fu) console per due volte e molto vicino politicamente a Marco Aurelio. Alla morte di quest'ultimo gli successe il figlio Commodo che entrò subito in contrasto con la sorella relegandola in secondo piano e tenendola lontana dal contesto politico e decisionale. Questo non fu accettato dell'Augusta che ordi' un piano per eliminare Commodo ma lui riuscì a salvarsi ed ovviamente la vendetta fu da par suo. Fece uccidere molti dei congiuranti ed esilio' a Capri Lucilla ( isola di residenza dorata per Tiberio, che fu adibita a luogo di esilio, costrizione e morte da alcuni imperatori, anche da Caracalla) dove di lì a breve la fece uccidere. Era l'anno 182 d.C. ed aveva circa 34 anni. Il sesterzio da esame diretto risulta coniato, centrato, con discreto metallo, buon peso e modulo ed ha svolto con evidenza la sua funzione. Ciò che mi spinto ad acquistarlo è il ritratto sorridente che si può ammirare ( ed anche la sua somiglianza con la madre Faustina Minore) che si contrappone in un certo senso a quello che purtroppo il triste destino, aiutato anche dal suo operato, gli riservo' ..... Condivido anche i miei denari tra i quali uno del Limes. Grazie ed alle prossime ANTONIO 31 mm 24,12 g RIC 17792 punti
-
Salve , segnalo : Il volume espone i risultati dello scavo archeologico di S. Egidio a Campo Imperatore, piccola chiesa pastorale posta a 1680 metri di quota nel cuore del Gran Sasso. Luogo di culto e ospizio per tutto il Medioevo diviene in seguito rifugio per i pastori che d’estate vi stanziavano con i loro animali, funzione che ha mantenuto fino al secolo scorso. Un’analisi archeologica, dunque, che per la prima volta riguarda quel grande fenomeno economico e sociale che è stata la transumanza tra l’Abruzzo e la Puglia. Lo scavo ha restituito diverse tipologie di reperti importanti, ceramici e devozionali, tra i quali si segnalano le borracce del pellegrino e le medagliette votive. Nella consistente quantità di reperti metallici spiccano le monete, con i numerosi falsi d’epoca, e i proiettili di archibugio, utili a restituire la dimensione quotidiana della vita dei pastori dal Medioevo fino al Novecento. Infine, sono state portate alla luce alcune sepolture medievali degli stessi pastori e una sepoltura anomala: si tratta di un individuo ucciso con fendenti di spada e deposto in posizione prona secondo un rituale esorcizzante atto a impedire il “ritorno” nel mondo dei viventi. Sarà disponibile da inizio dicembre. https://www.edizionidandrea.com/2 punti
-
2 punti
-
Altro bel video, stavolta riguardante la serie dell’aquila araldica di Vittorio Emanuele III. Tra i vari esperti di Bolaffi, personalmente il mio preferito è il sig. Barzan. Mi piace molto la sua impostazione nel raccontare la storia che accompagna queste monete.2 punti
-
Scusa esistono cataloghi di monete e si inizia con lo studiare quelli. Poi c'è l'esperienza sul campo.1 punto
-
Hai ragione in pieno @Ale75 Mi sono fidato troppo del diametro indicato... Non è facile comunque con la moneta in quelle condizioni, ma si vede adesso che me lo hai fatto notare la linea di esergo in corrispondenza della parola DVX confermo la tua identificazione!1 punto
-
La moneta mi piace, il dritto e' davvero espressivo. Il rovescio e' particolare, con tanti simboli religiosi collegati al culto di Vesta: l'altare acceso ai piedi, il simpulum nella mano destra ed il palladium (con scudo e lancia) nella mano sinistra. Ciao. Stilicho1 punto
-
Anche nel piccolo della Numismatica il valore umano fa la differenza per esempio permette di avere una sala piena.1 punto
-
DE GREGE EPICURI Confermo quanto indicato da @Vietmimin La moneta è collocata nel 1° secolo a.C., ed è classificata : La Tour 8086, Delestrée-Tache 675-676. Quanto al valore, posso dire che due esemplari sono stati presenti nel listino "Celtic V" di cgb del 2012 (p. 130), ed il migliore era valutato 280 €.1 punto
-
Esatto. Trattandosi di una moneta particolare, oserei dire di nicchia, al momento non reputo opportuno divulgare pubblicamente quello che so. Del resto una persona che ha avuto, a titolo completamente gratuito, sia chiaro, la spiegazione sulla moneta in suo possesso, non ha ritenuto di divulgare quanto da me esternato. Quindi, al momento rimaniamo cosi.1 punto
-
E anche un autogol da parte dei funzionari della Zecca che sono stati bravi a far emergere le irregolarità commesse. Purtroppo nel mondo della Numismatica ci sarebbe molto da riscrivere.1 punto
-
Riflessioni su una FEL TEMP REPARATIO Valuta questa discussione Da Stilicho 5 Luglio, 2022 in Monete Romane Imperiali Intanto un grazie speciale, mi hai fatto trovare la tua discussione, molto interessante e accurata. Ovviamente la mia moneta è talmente consunta che si può immaginare sia quella da tè indicata, ma per mè è una grande soddisfazione comunque.1 punto
-
Ciao @elledi. Hai sganciato una bomba a Idrogeno. Se esiste il modo per discriminare tra monete coniate nel 1901 e coniazioni postume e può essere dimostrato in maniera rigorosa, probabilmente andrebbe scritto un articolo a riguardo. Comprendo e condivido il fatto di non condividere tale informazione su un forum, che non è un ambiente consono (su un forum tali info possono essere inserite dopo). La pubblicazione in rivista con annessa revisione tra pari può dare molta forza a quella che fin quando non scritta nero su bianco rimane solo una (molto) autorevole ipotesi.1 punto
-
È arrivato novembre e - anzichè andare in letargo - è arrivata una Calopteryx splendens („Gebänderte Prachtlibelle" / Libellula bandata? C'è un entomologo tra di noi?) questa volta alla zecca "J" di Amburgo, queste monete le hanno coniate di lunedì: ho posizionato la luce in modo che i graffi venissero fuori senza pietà e manca anche in gran parte quel bell'effetto satinato delle altre. Ne ho tre, di nuovo prese direttamente alla Bundesbank, tutte simili nei difetti. Magari @pato19 ci può aggiornare, mai che - come al solito - gli capiti sotto mano un rotolino =========== L'alberello cresce! ho finito il filamento verde scuro, ne ho usato uno un po' più chiaro, tanto anche in natura la diversità impera. =========== FUN FACT: ho usato un "Ape" per pagare, ma ero ad una fiera ed ho preso questo bilgietto, per un attimo il venditore c'è rimasto, ma poi la ha presa 😁 Qui ci si rivede nel 2024, per quest'anno è tutto! Njk1 punto
-
Autunno ricco di pratica collezionistica per me. Riflettendo sulla marca identitaria della o del collezionista, mi verrebbe da dire che noi esperiamo la profondità della scissione. Ci occupiamo di ricostituire qualcosa di scisso. Potrebbe essere una vecchia collezione oppure un'antica serie monetale greca, qualcosa che il tempo ha disperso e che noi cerchiamo di ricostituire. Siamo forse nostalgici di un'unità che si è persa. Nella costituzione delle nostre collezioni percorriamo lo spazio-tempo. Lo facciamo in senso metaforico, ma neanche tanto. Capita infatti che ci si sposti da parte a parte del paese per recuperare quel dato pezzo. L'oggetto del nostro desiderio collezionistico, perso chissà dove, muto in contesti che non sono i suoi, torna a essere traccia indelebile di una storia, di una presenza, quando interrogato. Ecco tornare le parole di Quinto Sertorio: Abbiamo nostalgia di completezza. L'horror vacui è questione tremendamente umana, dunque anche collezionistica.1 punto
-
Questa è la base del collezionismo. E bene che sia così. Pensa se a tutti piacessero solo le oselle d'oro... Arka P.S. Le oselle mi piacciono molto, ma in argento. Bellissima la rosa di @Giov60... Diligite iustitiam1 punto
-
Mi accodo alla fila dei non veditori di filigrana. Allego foto rigirate per un più semplice raffronto. Mah, sarebbe davvero bello avere foto migliori. Certo che questa, più che non emessa, sembra emessa in lavatrice 🤷♂️1 punto
-
Bellissima iniziativa. Peccato che Roma, da anni, non offra più nulla di questo livello... Fabio1 punto
-
Non ci sono dati per dire esattamente a quali funzioni servissero, ma solo ipotesi. Pertanto per le “contromarche” preferisco fare la distinzione tra contromarche così come il Gnecchi: ”Le Contromarche, come più evidenti e più facilmente spiegabili o interpretabili, perchè contenenti in sé stesse la chiave dell’interpretazione, e del resto poco numerose, attirarono già da tempo l’attenzione del numismatico, furono da molti studiate e in gran [p. 22 modifica]parte più o meno felicemente spiegate; rimanendo così oramai chiarito che in generale servirono a indicare la riammissione ufficiale al corso legale di monete (per lo più di bronzo), le quali per quanto logore non avevano perduto il voluto peso. I Contrassegni invece, immensamente più numerosi nelle loro varietà, ma assai meno visibili per la loro piccolezza, si trovano quasi unicamente sulle monete d’oro e d’argento; e, non avendo un significato diremo implicito, come sfuggono alla descrizione, — talché non c’è altro mezzo di esprimerle che la riproduzione col disegno, — sfuggirono parimenti per lungo tempo allo studio non solo, ma anche all’osservazione dei numismatici.” https://it.wikisource.org/wiki/I_contrassegni_sulle_monete_della_Repubblica_e_del_principio_dell'Impero1 punto
-
1 punto
-
Salve @joannes carolus È un bronzo dei Remi o dei Carnuti. al dritto, testa maschile con un torque AΘIIDIACI : Athiidiacos? al rovescio, legenda A. HIR. IMP: Aulus Hirtius Imperatore. Aulo Irzio, propretore della Gallia comata nel 45 a.C (l’autore dell’ottavo libro del De Bello Gallico) un altro esemplare: https://www.acsearch.info/search.html?id=1287761 punto
-
I lingotti da 7,8 grammi non possono essere che 5 per ottenere un numero poi suddivisibile per pezzi da 7,5 o 8,5; il resto è facile 7 lingotti da 7,5 grammi (52,5) 1 lingotto da 8,5 grammi 5 lingotti da 7,5 grammi (39)1 punto
-
https://www.acsearch.info/search.html?term=Quattrino+Filippo+IV+&category=1-2&lot=&date_from=&date_to=&thesaurus=1&images=1&en=1&de=1&fr=1&it=1&es=1&ot=1¤cy=usd&order=01 punto
-
Un conto è il valore dell'oggetto in sé come argento, un altro il costo di produzione dell'oggetto (dall'ideazione del soggetto al conio e confezionamento), e questo vale per tutto, non solo per le monete (o pensi, che ne so, che un iPhone costi ad Apple 1800€?)1 punto
-
Buonasera Apollonia, sono Matteo e sto cercando di pulire delle sterline d'oro, da quello che ormai ritengo essere uno strato di nerofumo che vi si è depositato. Ho provato a lasciarle 5 giorni in acqua e sapone ma non è successo molto, poi ho lasciato 12 ore in acetone puro e qualcosina è successo, ma un po' poco, la moneta di destra è quella messa in acetone, poi sciacquata e strofinata un bel po' con i polpastrelli e il sapone, in acqua calda per pulirla. Ho anche provato, sempre sulla stessa diluente nitro, acquaragia, trementina, acido per pulizia piastrelle, ma l'unica cosa che ha fatto riemergere l'oro sul bordo, è stato il duraglit, ma mi sono fermato subito. Ora ho rimesso tutto in acqua e sapone. Accetto consigli. Sembra che siano avvolte da una sottile pellicola nera dura a venir via... che fare? Le ho misurate e pesate, e sono 22,06/22,08 mm * 1,52/1,54 mm, peso 8,5 grammi circa. Devo provare con la vaschetta ad ultrasuoni? Se si con che prodotto? Oppure altro? Grazie1 punto
-
La medaglia e databile nella seconda metà del XVII sec. ( dopo il 1671) , i due santi Domenicani furono canonizzati il 12 aprile 1671 da papa Clemente X. non comune. Ciao Borgho1 punto
-
mi ricorda un esemplare babilonese del IV millenio aC, ma quelle erano di coccio, non in metallo!1 punto
-
Bravo. Complimenti. Le descrizioni nei cataloghi dovrebbero essere più corrette. Ottimo veramente.1 punto
-
Tornando al tema 15 grani ecco uno stemma reale del 1618. Foto fatta da me 🤓1 punto
-
ciao @DiviAugusti Regno di Cilicia, Philopator II ? 14-17 d.C https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/1/3872 Se i dati, peso e diametro corrispondono.1 punto
-
Monete, resti di armamenti, ex voto degli antichi romani, Giano bifronte. Tempio e teatro. Cosa sta rivelando il santuario del mulino bruciato? A Estrées-Saint-Denis, nell’Oise, in Francia un complesso santuario gallo romano è al centro di studi e di scavi. L’area del sito archeologico è denominata “Moulin Brûlé”. Posizionato sulla cima di un’altura naturale, 87 metri sopra il livello del mare, questo luogo ha rivelato tre monumenti principali, ciascuno testimone di diverse fasi storiche che vanno dalla Seconda Età del Ferro al Tardo Impero romano. Le indagini condotte dall’Inrap hanno illuminato la complessa storia di questo antico centro, svelando dettagli su un recinto consacrato, un tempio e un edificio per spettacoli. L’Inrap stesso ne ha dato notizia in queste ore, dopo un accurato studio dei materiali e dei resti. Siamo davvero al cospetto di uno spazio protetto, collocato su un rilievo del terreno, in cui avvenivano liturgie religiose e che offriva ai fedeli spazi per la preghiera. Un santuario attivo e ricco di iniziative come dimostra la presenza di un teatro. Parti di depositi rituali di origine militare dimostrano che il luogo era frequentato anche da soldati. “Una buca di posta lungo il muro sud del tempio iniziale ha rivelato un lotto di 13 monete galliche. – spiegano gli archeologi dell’Inrap – Appartengono tutte ad una facies regionale, in un range cronologico -60 / +50 (100), ad eccezione di due monete forse più antiche, la cui prima data di emissione risale al 150 a.C. Un piccolo oggetto indeterminato completa questo lotto monetario. Realizzato in lega di rame, assume la forma di un nocciolo di oliva. Un secondo oggetto della stessa costruzione è stato rinvenuto in una buca di posta adiacente, mentre un terzo, proveniente dal bottino del tempio, proviene sicuramente dall’una o dall’altra di queste strutture. Si tratta di tre pezzi di forma e dimensioni quasi simili (31×9 mm; circa 8,80 g). può essere paragonato ad un oggetto identico proveniente dal santuario di Fesques (Seine-Maritime)”. Un singolare oggetto con l’effigie di Giano bifronte, scoperto durante gli scavi © Clichés/DAO : S. Lancelot, Inrap E veniamo alla seconda fase del tempio. Anche in questo caso i gallo-romani portarono offerte. “Qualunque sia il periodo considerato, i reperti archeologici rinvenuti, soprattutto metallici, sono piuttosto caratteristici dei contesti santuariali. – spiegano gli archeologi dell’Inrap – Comprendono monete, ornamenti (fibule, perle potin), due ruote, anelli, pezzi di armamento (tre rivetti umbone, un grande rivetto a scudo) ed elementi di finimenti e finimenti (morsi, chiodo smaltato, anello guida). All’altezza della torre del portico, all’ingresso del recinto, è stato rinvenuto un singolare oggetto recante l’effigie di Giano, il dio bifronte ma anche degli inizi, dei passaggi e delle porte. Trovato anche un cursore dell’equilibrio, un oggetto militare, deviato dalla sua funzione primaria e bruciato. Infine, molti di questi manufatti furono oggetto di mutilazione intenzionale”. Uno dei reperti: una rotella metallica. Aveva la funzione di ex voto? © Samuel Guérin, Inrap I misteriosi oggetti a forma di nocciolo d’oliva © Inrap E ci sono poi questi oggetti metallici simili a noccioli d’oliva o ai piombi che biconici che si usano – oggi – per la pesca sportiva. Cos’erano quegli oggetti? Si può supporre che simulassero i micidiali proiettili lanciati dai frombolieri? Il recinto consacrato: uno spazio evolutivo La parte meridionale del sito rivela i resti di un recinto quadrangolare molto antico, il cui angolo sud-est è stato accuratamente esplorato. Questo recinto, risalente alla Seconda Età del Ferro (circa 360-210 a.C.), suggerisce uno spazio circondato da buche e fosse, con tracce di una palizzata ad est. La presenza di un ampio ingresso, delimitato da quattro buche per pali, indica una funzione significativa. Successive trasformazioni vedono il recinto evolversi in una struttura piena di fossati, con un portico d’ingresso più elaborato e spazi semi-interrati. Questa fase, datata tra il 50 a.C. e il 30 d.C., rivela un edificio circolare, forse di culto, con una pianta di circa 12,50 metri quadrati. Il complesso del santuario diviene più forte e imponente. La seconda metà del I secolo segna, infatti, un cambiamento monumentale, con il recinto che viene trasformato, con opere in muratura. Gallerie porticate emergono, seguendo in parte il percorso del recinto originale, e una “torre porticato” sostituisce il portico in legno. Questo complesso, esteso su circa 2116 metri quadrati, potrebbe essere stato occupato per tutto il II secolo, abbandonato alla fine dello stesso secolo o nella prima metà del III secolo. Reperti archeologici, in particolare manufatti metallici e un oggetto raffigurante Giano, il dio bifronte, forniscono un affascinante affaccio sulla vita e sulle pratiche religiose del luogo. Il tempio: un luogo sacro di trasformazione La porzione settentrionale del sito rivela i resti di un tempio, caratterizzato da due fasi costruttive successive. Il primo tempio, in legno, occupa un’area sacra racchiusa da una palizzata. Con una pianta absidata, questo edificio del 50-30 a.C. potrebbe aver ospitato un focolare o un altare. Una buca di posta lungo il muro sud ha rivelato un tesoro di monete galliche, offrendo un’interessante finestra sulle attività economiche della zona. La trasformazione successiva vede il tempio evolvere in una struttura in muratura, con una cella di circa 17 metri quadrati. Un pozzo, forse sormontato da un’edicola circolare, e la presenza di elementi mobili suggeriscono un abbandono alla fine del II secolo o all’inizio del III secolo. Il palazzo degli spettacoli: un teatro antico di rara eleganza Lo scavo dell'”orchestra” del teatro contenuto nel recinto sacro © S. Guérin, Inrap L’edificio degli spettacoli, uno dei soli otto teatri antichi nell’Oise, sorge sul punto più alto del sito. Due fasi costruttive si delineano: un’originaria costruzione in legno, datata tra il 50 a.C. e il 27 a.C., seguita da una versione più monumentale in muratura. La facciata diametrale del teatro, lunga 68 metri, comprende un muro scenico decorato con cornici modanate e elementi statuari. Il palco rettangolare, noto come pulpitum, occupa una superficie di circa 60 metri quadrati. L’emiciclo della cavea, sebbene non ancora completamente compreso nelle sue dimensioni, suggerisce una capacità di 3000-4000 posti. Il teatro sembra essere stato occupato fino alla fine del II secolo, abbandonato nella prima metà del III secolo. https://stilearte.it/monete-resti-di-armamenti-ex-voto-degli-antichi-romani-giano-bifronte-tempio-e-teatro-cosa-sta-rivelando-il-santuario-del-mulino-bruciato/ L’ENCLOS CONSACRÉ Dans la moitié sud du site sont apparus les vestiges d’un enclos quadrangulaire dont seul l’angle sud-est a pu être fouillé. Trois états de constructions ont été reconnus. Un enclos palissadé ? La première construction semble correspondre à un espace ceinturé par des structures de type trous de poteaux et fosses, dont une partie, à l'est, coïncide probablement avec l’élévation d’une palissade, ainsi qu'une large entrée matérialisée par quatre trous de poteaux. Dans l'un de ces derniers, de forme ovalaire, a été mis au jour un contenant en matière périssable (boîte en bois ? en cuir ?) en position quasi-centrale. Outre quelques gros charbons de bois, y ont été découverts sept tessons, la moitié d’une grosse perle en calcaire coquillier et plusieurs gouttelettes et/ou micro-scories de bronze, ainsi que des semences de caméline, des grains d’orge, de blé amidonnier et de céréales indéterminées, des fragments d’une matière organique évoquant de la mie de pain ou de galette, ainsi qu'un nombre important de semences de gesse cultivée/gesse chiche. Les analyses ont démontré que cette première occupation se met en place au second âge du Fer, autour de 360-210 av. J.-C., et perdure au moins jusqu’à 160 av. J.-C. Or, la gesse est quasiment absente en Picardie et en Île-de-France à cette période. Aussi, sa présence en quantité élevée tend à évoquer un dépôt primaire ou un dépôt de fondation. Un enclos fossoyé et un bâtiment circulaire Le deuxième état de construction paraît indiquer une transformation de l’espace palissadé en un enclos fossoyé. Celui-ci reprend pratiquement le même tracé que la palissade. Le porche d’entrée devient plus important et des espaces semi-enterrés sont aménagés de part et d’autre. La voie qui mène à l’entrée est elle-même bordée de poteaux, de nouvelles palissades étant peut-être dressées. Selon le mobilier retrouvé, cet enclos aurait été occupé de 50 - 30 av. J.-C. jusqu’à la fin du règne de Néron (54 apr. J.-C.), avant dernier empereur de la dynastie julio-claudienne. Évolution de l’enclos consacré et focus sur le bâtiment de plan circulaire. © Topographie : Sébastien Hébert ; DAO : S. Guérin, Inrap À l’intérieur de l’enclos, dans l’angle sud-est, 9 trous de poteaux déterminent le plan d’un bâtiment circulaire d’environ 4 m de diamètre (soit près de 12,50 m²), précédé à l’est d’une possible entrée signalée par deux autres trous de poteaux. Les édifices de plan circulaire et ovale ne sont pas inédits aux époques laténienne et pré-augustéenne. Pour preuve, le sanctuaire du « Moulin des Hayes » (Estrées-Saint-Denis) a lui aussi livré plusieurs bâtiments similaires, interprétés comme des espaces sacrés et/ou réservés à des entités sacrées. Un enclos maçonné C'est au cours de la seconde moitié du Ier s. apr. J.-C. que l’enclos est monumentalisé et pérennisé dans la pierre. Bien que cet ensemble nous soit parvenu uniquement à l’état de fondations, on constate qu’une fois les fossés comblés, des galeries à portiques sont élevées, reprenant en partie le tracé de l’enclos fossoyé. Cependant, pour ne pas réduire l’espace intérieur de la cour, l’emprise des galeries est reportée à l’extérieur des fossés (sur les côtés notamment). Enfin, une entrée monumentale de plan carré – la « tour-porche » – vient se substituer au porche en bois. La superficie minimum de cet ensemble est d’environ 2116 m², si l’on se base sur la façade orientale longue d’environ 46 m. Ce monument pourrait avoir été occupé durant tout le IIe s., avant d’être définitivement abandonné soit à la fin de ce même siècle ou au cours de la première moitié du IIIe s. Secteur 1 : photographie aérienne de l’enclos romain présentant les fondations d’une galerie de circulation et d’une tour-porche. Arc de Dierrey – « Le Moulin Brûlé », Estrées-Saint-Denis (Oise), 2014. © Pascal Raymond, Inrap/Mehdi Belarbi, Inrap. Quelle que soit la période considérée, le mobilier archéologique mis au jour, notamment métallique, est assez caractéristique des contextes de sanctuaires. Il comprend des monnaies, des parures (fibules, perle en potin), deux rouelles, des anneaux, des pièces d’armement (trois rivets d’umbo, un grand rivet de bouclier) et des éléments d'attelage et de harnachement (mors, clou émaillé, anneau passe-guides). Un objet singulier à l’effigie de Janus, le dieu aux deux visages mais aussi dieu des commencements, des passages et des portes, a quant à lui été mis au jour au niveau de la tour-porche, à l’entrée de l’enclos. Il s'agit d'un curseur de balance, détourné de sa fonction première et brûlé. Enfin, plusieurs de ces artefacts ont fait l’objet de mutilations intentionnelles. Après un hiatus, le secteur sera partiellement réinvesti à compter de l’an 325 jusqu’à la fin du IVe s., voire le début du siècle suivant. On constate en effet qu’un long fossé de drainage et un puits recoupent en totalité la galerie à portique sud. LE TEMPLE Dans la moitié nord de l’emprise, les vestiges d’un temple ont été mis en évidence. Deux états de construction successifs ont été reconnus. Un temple sur poteaux plantés et un dépôt de fondation Le temple dans son premier état a été découvert à la faveur d’un décapage consistant à démanteler les fondations du temple romain qui lui a succédé. Ce premier édifice en bois s’inscrit dans une aire sacrée (temenos) d’au moins 437 m² (23x19 m) clôturée par une palissade (le péribole). De plan absidal et ouvert a priori vers l’ouest, ce temple primitif, s’élevant sur dix poteaux, occupait une surface de 39 m². Il est possible qu’il ait abrité un foyer ou un autel, mais il n’en subsiste aucune trace. Enfin, le mobilier archéologique indique que ce temple fonctionna au cours de 50 - 30 av. J.-C. à la période julio-claudienne (entre 27 av. J. -C. et 68 apr. J.-C.). Secteur 2, emprise du temple gaulois (Ier s. av. notre ère). Arc de Dierrey – « Le Moulin Brûlé », Estrées-Saint-Denis (Oise), 2014. © Samuel Guérin, Inrap Un trou de poteau bornant la paroi sud du temple initial a livré un lot de 13 monnaies gauloises. Toutes appartiennent à un faciès régional, dans une fourchette chronologique -60 / +50 (100), à l’exception de deux monnaies qui sont peut-être plus anciennes, leur première date d’émission remontant à 150 av. J.-C. Un petit objet indéterminé vient compléter ce lot monétaire. Réalisé à partir d’un alliage cuivreux, il prend la forme d’un noyau d’olive. Un deuxième objet de même facture a été découvert dans un trou de poteau adjacent, tandis qu’un troisième, issu des déblais du temple, provient certainement de l’une ou l’autre de ces structures. Ces trois pièces de forme et de dimensions quasi similaires (31x9 mm ; environ 8,80 g). peuvent être assimilés à un objet identique issu du sanctuaire de Fesques (Seine-Maritime). Objet indéterminé en forme de noyau d’olive rréalisé à partir d’un alliage cuivreux. © Inrap Un temple maçonné Les fondations maçonnées du temple à plan centré, appelé fanum, ont succédé au temple primitif en bois ; il en est de même pour l’emprise du péribole. Les limites de l’aire sacrée ne sont pas connues, mais on constate que le fanum n’était pas centré dans le temenos. De plan presque carré, la cella mesure environ cinq mètres sur six de côté, pour un espace interne d’environ 17 m². L’édifice est fondé sur un radier de silex assez dense, de même que la galerie de circulation, de 10,50 m de côté et de 1,50 à 2 m de large, les déambulatoires mesurant environ 9 m de long. Seule une partie des fondations des murs nord, est et sud du péribole ont été mises au jour. Par ailleurs, un puits est localisé à l’extérieur de l’espace sacré, mais proche du mur nord du péribole. Ce puits était probablement coiffé d’un édicule circulaire. Sondé jusqu’à 5 m de profondeur, il a livré quelques éléments mobiliers qui suggèrent un abandon à la fin du IIe s. ou au début du IIIe s. Bâti à la fin de la première moitié du Ier s. apr. J.-C. ou dans le courant de la seconde moitié du Ier s., le temple a été désaffecté lui aussi durant la première moitié du IIIe s. Évolution du temple en bois vers le fanum maçonné. En haut, à droite : fragment d’orle de bouclier découvert dans St.126 et talon à douille conique d’arme d’hast mis au jour dans le niveau 1033 (temenos) ; en bas, à droite : petits objets indéterminés en forme de noyau d’olive découverts dans St.437 et 445. © Topographie : Sébastien Hébert ; clichés : S. Lancelot ; DAO : S. Guérin, Inrap L’ÉDIFICE DE SPECTACLE L’édifice de spectacle compte parmi les huit théâtres antiques recensés dans l’Oise. Il a été construit sur le point le plus haut de l’éminence naturelle, alors que le temple qui lui fait face, s’élève sur un léger versant exposé au nord. Entre les deux, une longue esplanade (porticus post scaenam) de plan quadrangulaire permet la circulation entre les deux monuments. Deux états de construction ont été identifiés pour le théâtre (fig. 4). En effet, une série de structures en creux suggère qu’une construction en bois précéda le monument en partie maçonné (état 2). Secteur 2 (plan) : esplanade localisée à l’arrière du théâtre romain (Ier-IIe s. apr. notre ère). Arc de Dierrey – « Le Moulin Brûlé », Estrées-Saint-Denis (Oise), 2014. © Samuel Guérin, Inrap Un premier théâtre construit en bois Le plan de l’édifice de spectacle dans son deuxième état reprend celui d’un édifice primitif, de plus petite dimension, dont ont été identifiés l’axe de la façade diamétrale, l’emplacement supposé de la scène et une partie de l’emprise de la cavea. Lors du décapage des fondations de la façade diamétrale maçonnée, les fonds de trous de poteaux alignés, distants les uns des autres d’environ 1 m, sont apparus. Une structure construite sur ossature bois semble donc avoir constitué cette première façade, sa longueur restituée étant d’environ 50 m. Le dispositif scénique était intégré au centre de celle-ci, à cheval entre l’esplanade qui la borde à l’extérieur et une aire trapézoïdale localisée devant la scène (vestige d’une orchestra ?). Les dimensions de cette scène sont évaluées à 10 m de long contre environ 4,50 m de large, soit une surface d’environ 45 m². Structures rectangulaires interprétées comme les fosses d’implantation de pieux verticaux qui bordaient la cavea primitive. © Cliché : S. Guérin, Inrap À environ 8 m au sud de la façade diamétrale maçonnée, une aire en forme de demi-cercle prolongé par deux lignes parallèles est circonscrite par une succession de vingt fosses interprétées comme les fosses d’implantation de pieux verticaux qui bordaient la cavea. Du côté nord, une tranchée était probablement destinée à recevoir une poutre de sablière basse, limitant l’emprise de la cavea de ce côté-ci. Finalement, l’ensemble de ces structures a vraisemblablement été aménagé dans le but de contenir une partie des remblais qui constituaient la pente de la cavea. Il pourrait aussi concerner un dispositif supportant une cavea construite intégralement en bois, comme sur le site de Boult-sur-Suippe, à 15 km de Reims, où des fosses rectangulaires semblent avoir servi à l’implantation de pieux verticaux permettant de contenir une partie du remblai interne de la cavea d’un édifice de spectacle en bois d’époque romaine. Dans le cas présent, il manque des données sur la nature des gradins : ces derniers étaient soit en bois, ou bien de simples talus concentriques ont été aménagés, tenant lieu de gradins gazonnés. Le théâtre primitif d’Estrées-Saint-Denis paraît avoir été édifié durant la période Pré-augustéenne (50-27 av. J.-C.), voire Augustéenne (27 av. J.-C./14 apr. J.-C.), ce qu’une datation C14 tend à confirmer. De fait, ce théâtre peut être considéré comme le plus ancien édifice de spectacle de l’Oise et, au-delà, comme l’un des plus anciens théâtres de Gaule Belgique. Secteur 2 : photographie aérienne du fanum et du théâtre. Arc de Dierrey – « Le Moulin Brûlé », Estrées-Saint-Denis (Oise), 2014. © Pascal Raymond, Inrap/Mehdi Belarbi, Inrap Le théâtre maçonné Dans son état maçonné, les vestiges de l’édifice de spectacle se résument pour l’essentiel aux éléments de fondation et aux tranchées de récupération. Sont ainsi conservés les murs périmétraux rectilignes et le mur de scène, les substructions de la scène, l’emprise de l’orchestra, deux tronçons de murs dans la cavea. Des observations réalisées à partir des bermes est et ouest de la fouille ont également permis de constater des apports de sables pour constituer le monticule artificiel sur lequel les gradins s’élevaient. À l’exception de l’hémicycle monumental encaissé, l’ensemble est très arasé. La façade diamétrale du théâtre maçonné est composée des murs rectilignes ouest et est qui encadrent un mur de scène plus large ; sa longueur est estimée à 68 m. Concernant le mur de scène (11 m de long), il possédait certainement une élévation plus importante, propre à recevoir des décors. C’est d’ailleurs précisément dans ce secteur qu’ont été mis au jour la plupart des éléments décoratifs. Si aucun placage n’a été découvert, en revanche trois morceaux d’une corniche moulurée, un fragment de colonne d’environ 60 cm de diamètre (pour 4 m de haut à l’origine) et trois éléments statuaires, dont un fragment de drapé, sont recensés. Ces derniers apportent un témoignage précieux quant à la présence d’une ou plusieurs statues (ou reliefs) au niveau du mur de scène, sans que l’on ne puisse en préciser davantage la position d’origine ni même identifier le ou les sujets qui étaient représentés (élite locale, figure impériale ou représentation divine ?). Adossée au mur de scène, l’estrade ou pulpitum est de plan rectangulaire pour une surface occupée d’environ 60 m². Son plancher était supporté par trois murs dont il subsiste principalement les tranchées d’épierrement. La scène occupe en grande partie la surface de l’orchestra, là où le chœur et les musiciens prenaient place. Cet élément architectural est le plus remarquable et le mieux conservé de l’édifice de spectacle. Excavée sur 0,50 m de profondeur, l’orchestra est délimitée au nord-ouest par le mur de scène et les murs périmétraux rectilignes, tandis qu’à l’opposé et latéralement, elle est cernée par un alignement de grandes pierres de taille disposées sur deux rangées. L’aménagement en grand appareil de l’orchestra forme un dispositif original ; 82 dalles en calcaire ont été nécessaires pour le concevoir. Il est interprété comme un couloir de circulation, ce qui est aussi le cas d’un dispositif similaire au théâtre antique de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Enfin, à l’arrière de l’orchestra s’ouvre l’hémicycle de la cavea formé par un monticule de remblais sableux, vraisemblablement maintenus dans la partie inférieure par l’aménagement en grand appareil. À ce stade des recherches, on ignore presque tout de l’emprise initiale de la cavea. En extrapolant sa forme en fonction de la longueur de la façade diamétrale, on obtient un plan semi-circulaire outrepassé. Cette hypothèse permet de restituer un théâtre de 68 m de long sur 60 m de profondeur, ce qui le rapprocherait de celui de Ribemont-sur-Ancre (Somme) construit peu après le milieu du Ier s. (capacité de 3000 à 4000 places). Bien que les accès à la cavea soient méconnus, on peut néanmoins se demander si des entrées latérales n’ont pas été aménagées le long des murs périmétraux rectilignes. Secteur 2, théâtre romain. Emprise supposée de la cavea (Ier-IIe s. apr. notre ère). Arc de Dierrey – « Le Moulin Brûlé », Estrées-Saint-Denis (Oise), 2014. © Samuel Guérin, Inrap Ainsi, le développement et la « pétrification » du monument semble être intervenue au cours du Ier s. apr. J.-C., sans plus de précision. Puis, le théâtre paraît avoir été occupé au moins jusqu’à la fin du IIe s., son abandon intervenant au cours de la première moitié du IIIe s. Enfin, si l’édifice de spectacle est le lieu indispensable pour accueillir la foule et concentrer son attention, celui-ci répond à plusieurs fonctions : il a certainement été le lieu de ludi scaenici (pantomimes et autres manifestations), mais aussi l’espace où se déroulèrent mystères et autres cérémonies religieuses en rapport avec la vie du sanctuaire.1 punto
-
E quindi ora …tutto con calma riprende, e chi volesse partecipare con l’entusiasmo che ho visto in questo numero 10, può già pensare a cosa scrivere per il futuribile numero 11 …1 punto
-
Per toglierti il dubbio perché non scrivi e ti fai inviare delle foto migliori (e riguardanti il bordo) ? Così ti levi il dente e verifichi. Come hanno già ben detto quelli che mi hanno preceduto, dovrebbero essere problemi fotografici, di luci, e di programmi grafici (diciamo che il tecnico ha fatto un pastrocchio) e non sulla genuinità delle monete. Secondo me con Bolaffi i veri problemi erano i prezzi stellari nei cataloghi per principianti, ma essendo il mercato libero ognuno decide di fare come gli pare.1 punto
-
1 punto
-
Se son quelle neanche valore affettivo... son durate talmente poco che uno non ha fatto in tempo ad affezionarsi petronius1 punto
-
credo che il mix tra: luci; programma di fotoritocco per colori/contrasto; e ritaglio/pulizia immagine, abbiano dato un risultato fotografico innaturale e "strano" ....1 punto
-
Buonasera a tutti, perdonate la mia latitanza.. @giuseppe ballauri @Asclepia, ripropongo nuove Foto della mia Napo. Taglio sembrerebbe a treccia. Assi alla Francese. Saluti Alberto1 punto
-
È qui mi fermerei...non credo che sia così interessante parlare dei discendenti di quel peccatore.... Effettivamente questa tesi ha senz'altro un fondo di verità scientifica! Credo che dovresti approfondire questa ricerca e poi magari pubblicarla, naturalmente solo su periodici a colori e su siti specialistici e specializzatati...1 punto
-
1 punto
-
@Adelchi66 non me lo aspettavo da te: adesso fai del body shaming ? Se erano dei Celti di bassa statura ?1 punto
-
Per favore: ti pregherei di correggere il titolo...Cenonani non si può proprio leggere.1 punto
-
Concordo con @ilnumismatico, si tratta di due belle monete, con anche un bel lustro, credo valgano certamente più di 5 euro.1 punto
-
Buon pomeriggio, a proposito di lettere grosse, vorrei sfatare la leggenda - riportata come nota su tutti i cataloghi - riguardo la data 1856 come anno dell'introduzione del nuovo carattere dalle lettere più grosse sulle Piastre di Ferdinando II. La napoletana di oggi è una Piastra 1839 che al rovescio presenta un rarissimo conio con le lettere grosse. Allego le immagini di una moneta che due anni fa passò all'asta 64 di Nomisma.1 punto
-
Salute ho ricevuto ,su un mio social che frequento, questo bel pezzo molto interessante scritto su"Tribunus" e ritengo che sia valido per questa sezione: 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗦𝗶𝗹𝗼. 𝗜𝗹 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗲𝗿𝗿𝗼. Se vi parlo di guerrieri con protesi metalliche, ai più esperti e appassionati non potrà che venire in mente il cavalieri di XV secolo Götz von Berlichingen, del quale sono arrivate fino a noi ben due delle sue protesi di ferro, indossate anche in combattimento. Tuttavia, esiste un precedente già nel mondo romano, che curiosamente ai più è oggi ancora meno noto di Götz von Berlichingen: Marco Sergio Silo. La vicenda di Marco Sergio Silo ci è nota dalla 𝘕𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘪𝘴 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 di Plinio il Vecchio, il quale ci riferisce che ha estrapolato le notizie che riporta dalla trascrizione di un discorso di Silo stesso - e vedremo, alla fine del post, i motivi dietro tale discorso. Marco Sergio Silo è un illustre antenato del famoso Catilina (il quale, secondo Plinio, "offuscò l'onore del suo nome"). Da quanto ci racconta Plinio, che non ci fornisce purtroppo grandi dettagli sulle imprese di Silo e di quando queste hanno luogo, il Romano avrebbe perso la mano destra partecipando alla sua seconda campagna militare. Ci viene anche detto che nel corso di altre due campagne viene ferito ben ventitré volte, potendo a malapena usare la mano rimasta e i piedi, ma che ciò non lo avrebbe fermato dal proseguire a fare il soldato, per quanto invalido (sappiamo solo che è assistito da un suo schiavo). Non sembra improbabile che queste prime ferite e la perdita della mano abbiano avuto luogo nel corso della Seconda Guerra Punica. Infatti, sempre da Plinio sappiamo che viene catturato da Annibale ben due volte, e che in altrettante occasioni riesce a fuggire - anche se sembra meno chiara la specifica relativa a venti mesi ininterrotti di prigionia. Sembra probabile pensare che il primo tentativo di fuga sia andato male, portandolo di nuovo in catene. La parte che più nello specifico descrive le imprese di Marco Sergio Silo e la sua protesi è come segue: "In quattro occasioni combatté solo con la mano sinistra, con due cavalli abbattuti sotto di lui. Si fece una mano destra di ferro, fissata al moncherino, spezzò l'assedio di Cremona, difese Piacenza e catturò dodici accampamenti nemici in Gallia [Cisalpina]." Purtroppo i dettagli delle imprese di Silo non sono facilmente collocabili nel tempo, considerando anche che nessun altro autore antico menziona questo personaggio. Inoltre, senz'altro non conosciamo tutto nemmeno da Plinio il Vecchio: non sappiamo quando viene catturato da Annibale, né quali siano le "altre campagne", menzionate da Plinio, alle quali partecipa il Romano con la mano di ferro. L'unico dato certo è che abbia quindi partecipato alla Seconda Guerra Punica, probabilmente combattendo alle battaglie del Ticino e della Trebbia del 218 a.C. e partecipando alle successive azioni militari - come la difesa di Piacenza, durante la quale Annibale viene tra l'altro ferito. Tuttavia, nel corso di queste operazioni non è menzionato esplicitamente un assedio punico alla città di Cremona, principale base delle operazioni romane nel nord Italia insieme a Piacenza. Un'altra possibilità è che Marco Sergio Silo possa aver preso parte alla soppressione della rivolta gallica, guidata (secondo Tito Livio) dal cartaginese Amilcare, del 197 a.C., poiché sappiamo che in quell'occasione un esercito romano spezza l'assedio di Cremona. Non può aver tuttavia, in questa occasione, aver partecipato alla difesa di Piacenza, che viene infatti saccheggiata e data alle fiamme dai Galli sfruttando il fatto che sia quasi del tutto indifesa. Vi è anche la possibilità che abbia preso parte a entrambe le guerre, a molti anni di distanza l'una dall'altra. Tuttavia, al di là, come accennato, di prendere atto che Silo abbia preso parte alla Seconda Guerra Punica, il resto sarebbe purtroppo solo mera speculazione. Come accennato all'inizio, Plinio il Vecchio afferma di aver ricavato le informazioni su Marco Sergio Silo e la sua mano di ferro dalla trascrizione di un'orazione di quest'ultimo. Mentre è pretore, quasi certamente proprio nel già menzionato 197 a.C., Marco Sergio Silo è infatti costretto a ricordare i suoi meriti e le sue imprese, ai suoi colleghi, che lo vorrebbero escludere dai riti sacri proprio a causa della sua menomazione. Una menomazione che non gli ha impedito tuttavia di distinguersi come uno dei soldati più eroici di Roma e, nelle parole di Plinio il Vecchio, di "conquistare persino la Fortuna stessa." Salutoni odjob Conoscete qualche altra figura storica con menomazioni agli arti sopperite da protesi? In caso affermativo postate pure di seguito la storia di tali personaggi. Grazie1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+02:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







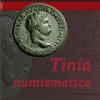








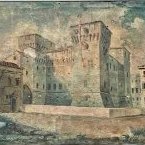




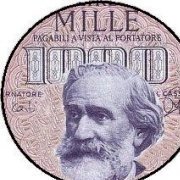
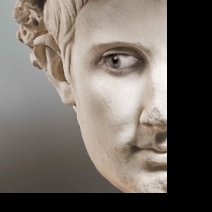












.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)