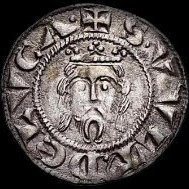Classifica
Contenuti più popolari
Elenco dei contenuti che hanno ricevuto i maggiori apprezzamenti il 07/01/14 in tutte le aree
-
Io ci provo ancora una volta, testardo come un mulo con una discussione che più generalista di questa non ci può essere, certamente investe l'era moderna, ma quella medievale pure e volendo un po' tutte. Coinvolge tutte le zecche, nessuna esclusa, tutti i periodi, l'argomento è di quelli più importanti e intriganti di tutta la numismatica, tutti i libri lo trattano, e non è certo un argomento difficile basta raccontare...., la discussione è stata preannunciata ora nella sezione curatori, tutti avvertiti.....ora vediamo come sarà la risposta, mi auguro sia un successo....anzi lo deve essere :blum:.... Delle pene e dei castighi.....di cosa parlo, ovviamente di monete false, di monete tosate, di illegalità varie.....ovviamente erano previste pene, alcune atroci, alcune di facciata, certo fu difficile arginare tutto questo..... Mi piace iniziare con quanto detto nel libro che fu dato alla presentazione a Milano della Mostra " Il vero e il falso " e introdurre qualcosa in generale, poi si potrà passare dal generale, al caso di zecca, al bando, al caso specifico del tal falsario.....e via dicendo.... " La gravità della pena è decisa anche in relazione al fatto che i falsari e i loro committenti, civili o spesso facenti parte di istituti religiosi, dovevano normalmente appartenere a un livello sociale piuttosto alto, il che permetteva loro di spacciare la moneta falsa. Sono numerosi infatti i casi di rinvenimento di tracce di officine di falsari all'interno di castelli, di conventi o di dimore signorili. La convenienza a produrre una moneta falsa imitante una autentica in circolazione deve essere legata strettamente al costo dell'operazione. Per questo motivo le monete maggiormente falsificate sono in oro e argento mentre la falsificazione di bronzo dava pochi utili ." Sulla tosatura invece ...." Un fenomeno che si incrementa a partire dalla fine dell'impero, quando i tondelli delle monete cominciano ad assottigliarsi, riguarda la tosatura ovvero la sottrazione di piccole parti di metallo mediante ritagli di bordo. La tosatura è di fatto una forma di alterazione della moneta ufficiale, un intervento non autorizzato che provocava, anzitutto, un immediato calo di peso per le monete, procurava illeciti guadagni agli autori e, spesso, obbligava le autorità al ritiro forzoso delle monete tosate. " Vediamo però anche qualche pena e castigo ora....5 punti
-
Evocato da Dabbene arriva un quattrino di Castro coniato dal suo primo Duca Pier Luigi Farnese, egli fu Signore del piccolo, ma importante Ducato, dal 1537 al 1545. Dei quattrini coniati a Castro se ne conoscono moltissime varanti, dovrei avere altre foto mi sembra, se le trovo le posto tra un po'. Ciao, Giò3 punti
-
Andrebbe vista dal vivo per valutare lo stato effettivo di conservazione, i rilievi sono splendidi ma spesso questo genere di piastra viene valutato anche dallo stato di usura dei fondi e non solo dei rilievi. A prima vista e dalle foto sarei propenso a classificarla con un ottimistico q.SPL.2 punti
-
@@nando12 dalla mia poca esperienza sulle monete napoletane , direi che un qspl lo merita tutto , aspetta però pareri più autorevoli del mio :)2 punti
-
Beh, a vedere tutti questi "mi piace" sono un po' preoccupato... Per quanto riguarda Genova (oltre alle pene capitali per i casi eclatanti) ho letto che tagliavano nasi, mani, orecchie e cavavano occhi ...ma credo che i più siano riusciti a restare impuniti o perché avevano "protezioni influenti" o perché riuscivano da soli ad "espatriare" per continuare la loro "arte" in posti meno pericolosi ...pare non mancasse la richiesta di "specialisti" ...2 punti
-
Ho terminato di leggere questo libriccino che chiamano rivista ma è proprio un libricino ed è fatto in maniera semplice ma ricco di contenuti. Dire che mi sia piaciuto un articolo rispetto ad un altro non ritengo sia giusto. La passione di questi ragazzi va premiata acquistando questo "Il Tondello"Vol.II Tutti gli articoli hanno un qualcosa che istruisce il lettore. Faccio un :clapping: agli sponsor Il volume ,comprese le spese di spedizione, costa solo € 102 punti
-
Come sempre complimenti a dabbene per la sua capacità di divulgaziione di temi numismatici divulgativi, in grado di coinvolgere tutti gli utenti. In attesa di documentarmi sul tema proposto, riguardo le zecche di mio interesse, vorrei sottolineare alcuni in primis, che il diritto di battere moneta (ius cudendi) spettava all'autorità statale, per cui si comprende come l'atto di falsificare la moneta sia stato considerato un delitto molto grave, comparabile con quello di lesa maestà e da qui deriva la gravità della pena inflitta. Uno dei falsari più celebri fu Mastro Adamo, il cui ricordo è reso immortale dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, che, per le falsificazioni dei fiorini d'oro di Firenze fu arso vivo nel 1281 e inserito, come cotrappasso dal Sommo Poeta nella decima bolgia, quella dei falsari. "Io son per lor tra sì fatta famiglia; e' m'indussero a batter li fiorini ch'avevan tre carati di mondiglia". (canto XXX, vv 88-90)2 punti
-
Ti ringrazio, ultimamente siamo in 2-3 al max che frequentiamo questo post con assiduità, io mi sono interessato a questo tipo di collezione solo pochi mesi fa, qui dentro ci sono altri membri più preparati di me su questa tematica, ma ultimamente la loro presenza latita...2 punti
-
Cara MAP le norme vanno sempre rispettate. La qualifica di bravo numismatico pero' e l'affidamento di progetti di responsabilità la si guadagnano con conoscenza, esperienza e pubblicazioni e non basta un pezzo di carta. Se un dottorando/to in numismatica è bravo porte apertissime ci mancherebbe, ma a quelli che vantano solo il pezzo di carta per reclamare un posto al sole allora preferisco chi ha "provato" di valere con articoli/libri/conferenze/gestioni di progetti etc. C'è un'Italia dei corporativismi che difende supinamente gli interessi di parte indipendentemente dalla validità di chi li reclama e c'è un'Italia aperta, imprenditoriale che accetta e sa condurre le sfide.Nella storia economica e culturale del nostro Paese queste due anime si sono alternate e convivono tuttora.. Vogliamo chiederci chi ha contribuito maggiormente alla crescita del Paese ? ;)2 punti
-
Non vorrei che i resoconti fatti da chi era presente all'evento di Milano abbiano fatto travisare la realtà della situazione in cui versa la regolamentazione del collezionismo italiano e i problemi a lungo dibattuti su queste colonne. Se un certo entusiasmo si è potuto percepire dagli interventi di cui sopra esso è dettato non tanto da un'auspicata svolta nell'atteggiamento dei funzionari del MIBACT, quanto dall'aver dato un segnale di apertura stabilendo un dialogo tra le parti, e venendo da anni di "vuoto pneumatico" dove anche iniziative lodevolissime quali quella ricordata ad opera di Bernardi sono andate a finire in nulla, un minimo progresso sulla situazione preesistente ha quantomeno ingenerato una parvenza di ottimismo. Nessuno si illude che qualcosa sia cambiato e concordo che il punto di vista di un legale deve necessariamente quello di basarsi sui fatti e non sulle aspettative. Tuttavia la vita "è" fatta di aspettative (guai a non averle!) e quindi giustifico pienamente anche le parole di Mario etc. che hanno colto alcuni timidi segnali di cambiamento e li hanno giustamente amplificati nelle loro aspettative. Di buon auspicio , tra l'altro, le parole di Polemarco che ci dà qualche elemento in piu' del cambiamento in atto , almeno in una parte della giurisprudenza. Continuo a voler convincermi che parlare di questi temi, qui sul Forum, ma anche in altre platee, convegni, arene, circoli, etc. alimenti alla fine una corrente di pensiero nell'ecosistema capace se non di influenzare almeno di non essere ignorata dagli attuali decision-maker della regolamentazione in ambito numismatico. E progressivamente, se le voci saranno coerenti e persisteranno, non si potrà non considerarle e recepirle nel lungo termine. Non vi è certezza , ma lasciateci almeno questa illusione :)2 punti
-
New entry, Pegione o Grosso da 1 e 1/2 soldi emesso dalla Zecca di Milano sotto Bernabò Visconti Signore di Milano ( 1378 - 1385 ). Catalogato da Crippa al 3 e dal MIR 112, con il grado di rarità R D/ + D.B.NABOS VICECOMES MEDIOLANI.ET.C R/ SAMBROSI MEDIOLANV Però la moneta in oggetto è una variante non catalogata dal Crippa ne dal nuovo MIR.1 punto
-
Cenni storici Prima di parlare della zecca di Lecce si rendono indispensabili alcuni cenni storici sulla figura del principe cui per primo va ricondotta la paternità della zecca cittadina : Giovanni Antonio Del Balzo Orsini conosciuto anche come Giannantonio, figlio di Raimondo Del Balzo Orsini e di Maria d’Enghien (che alla morte del marito divenne regina di Napoli sposando re Ladislao). Fu Principe di Taranto, Duca di Bari, Conte di Lecce, Acerra, Soleto e Conversano dal 1406, Signore di Altamura, nonché Conte di Matera dal 1433 e di Ugento dal 1453. Non a caso in una relazione inviata da Napoli, regnando Alfonso I il Magnanimo, si indicava Giovanni Antonio al primo posto tra i signori feudali del regno. Padrone di 400 castelli, 70 città vescovili e 30 città arcivescovili egli poteva viaggiare da Taranto a Salerno senza uscire dai propri domini :” Lo principo da Taranto è signore da per sé in lo Reame de più de quatrocento castelle. E comenzia il suo dominio da la porta del merchà de Napoli lunzi oto milya a uno locho se chiama la terra de Marignano e dura per XV zornade per fina in capo de Leucha; e chi lo chiama lo Sacho de terra de Otranto e dura per melya quattrocento e più. E li ve sono quante terre principale e grande oltra le castelle preditte et primo Tarrantina, dove è lo archiopisco, Vrindige, Lezza, Convertino, Otranto, Nardò, Mathera, Gallipoli, Insula de mare, Oyra, Miragna, Astone, Altamura, Minervino, Santo Pietro in Gallatina, Massafra, La terza, Castelanetha, Le gratalye, Ociento, Cassalnovo, Pallignano, Ascoli de Capitaniato, Rutilyano, Conversano, Gravina, La Cerra, Marignano, Chaliffri. Item lo principo anteditto de Taranto ha sotto di sé pillyato tutto lo ducato de Barri, da poi la morte de messer Jacopuzzo Caldora”. Pertanto con una tale consistenza patrimoniale, paragonabile a quella della stessa corona, il Principe poteva condizionare non solo la politica del regno ma, come vedremo, anche la successione al trono. Già precocemente egli venne coinvolto nelle lotte dinastiche per la successione al trono di Napoli. Nel 1421, la regina Giovanna II (sorella del precedente re Ladislao) aveva adottato come figlio ed erede Alfonso V re d’Aragona, quale REGINE DEFENSOR. Appena 2 anni dopo, scontenta dell’atteggiamento di Alfonso che intendeva esercitare anzitempo il potere regale, revocava l’adozione e disponeva nel proprio testamento che alla sua morte la corona passasse a Renato d’Angiò Valois Provenza (II casa d’Angiò) Denaro di Giovanna II d’Angiò ed Alfonso I d’Aragona (REGINE DEFENSOR) . Alla morte della regina (2 febbraio 1435) Alfonso, partendo dal suo regno di Sicilia, cercò di riprendersi con le armi il regno di Napoli. anche in considerazione del fatto che il pretendente angioino era prigioniero del duca di Borgogna che gli rivendicava il ducato di Lorena. Inizialmente Alfonso andò incontro alla sconfitta navale di Ponza da parte di una flotta genovese inviata dal duca di Milano Filippo Maria Visconti e fu fatto prigioniero insieme a Giovanni Antonio. Conseguentemente Isabella di Lorena, moglie di Renato, poteva raggiungere Napoli dove, ricevuta con tutti gli onori, governò come reggente per quasi 3 anni. Renato, riuscito a riscattarsi dal Borgogna, giunse a Napoli solo nel maggio 1438. Ma già 3 anni dopo Alfonso assediava la città partenopea, conquistandola il 2 giugno 1442. Renato si trovò così costretto a ritornare in Provenza quello stesso anno e , sebbene conservasse il titolo di re di Napoli, non ne recuperò mai il potere effettivo e restò pretendente fino alla sua morte (1480). Il 26 febbraio 1443 Alfonso fece il suo ingresso trionfale a Napoli, e risuscitando, da buon umanista, il corteo dei trionfatori antichi vi entrò su un carro dorato. Giovanni Antonio, Gran Connestabile del regno, che aveva contribuito in maniera determinante al successo dell’aragonese e alla sua ascesa al trono, desiderava condividere gli onori del vincitore e pretendeva pertanto di sfilare dietro al carro trionfale accanto al re e non avanti al carro, fra i baroni sottomessi con la forza dal sovrano. Tale arroganza indispettì il sovrano che diede ordine al maestro di cerimonia di far sfilare tutti i baroni dietro al carro trionfale, esattamente come si trova rappresentato nei marmi del monumentale ingresso di Castelnuovo Ingresso trionfale di Alfonso il magnanimo a Napoli: arco inferiore del portale di ingresso a Castelnuovo Fu allora che si incrinò la solidità della coesione tra gli interessi del barone più potente del regno e quelli della corona. Fu allora, dopo la vittoria, che “il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re “, ponendo i presupposti della reciproca diffidenza che da quel momento avrebbe caratterizzato i rapporti tra feudatario e sovrano. Tuttavia per la stabilità politica del regno s’imponeva, con urgenza, la necessità di assicurare a Ferrante, figlio bastardo ed erede designato di Alfonso a Napoli, il consenso della feudalità regnicola. Tale obiettivo poteva essere raggiunto solo attraverso un alleanza matrimoniale con il suo più influente esponente, il principe di Taranto che, in assenza di figli legittimi dal suo matrimonio con Anna Colonna ( nipote di papa Martino V), aveva nominato erede del principato la nipote Isabella Chiaromonte, figlia di sua sorella Caterina. Dopo le nozze tra Isabella e Ferrante (1445) sia il papa che i baroni riuniti nel Parlamento del regno accettano di riconoscere la successione del figlio naturale. Dopo la morte di re Alfonso ( 28 giugno 1458) Ferrante (Ferdinando I), successore designato Coronato di Ferrante I d’Aragona (rovescio) con scena dell’incoronazione di Barletta Sebbene invii prontamente segnali di pace ai pur sempre riottosi baroni, assicurandoli di voler governare “ con l’amore di lor signori “, i nemici di sempre si rifanno vivi ed in particolare i cugini aragonesi di Spagna ( con pretese di successione in luogo di “el bastardo”), i pretendenti angioini e molti baroni filoangioini del regno. Nuova molla alla sollevazione dei baroni (I congiura : 1459-1463) è la discesa in Italia (ottobre 1459) di Giovanni d’Angiò, figlio di re Renato e sedicente duca di Calabria. Giovanni d’Angiò Il principe di Taranto, grande assente alla cerimonia di Barletta, inizialmente assume posizioni ambigue e contraddittorie, ponendosi ora come interlocutore privilegiato del re, ai cui ambasciatori si dichiara suddito fedele, ora come sostenitore del pretendente angioino (Angiò-Valois-Provenza), non dimentico che i Del Balzo (De Baux) sono pur essi di origine provenzale. In pratica egli confina nell’ambito delle ipotesi non remote la possibilità di una propria aspirazione al trono di Napoli o almeno ad una iniziale reggenza come riporta il Nunziante (“lo Reame vivente esso principe lui lo habia ad regere et governare pro suo arbitrio voluntatis, cum protestate de togliere et de donare a chi meglio glie parerà “). Ma ben presto Giovanni Antonio appare evidentemente l’unico alleato su cui il pretendente angioino possa contare concretamente e diventa l’anima della rivolta, traendo dalla sua parte i potentissimi baroni filoangioini tra cui Marino Marzano, duca di Sessa e principe di Rossano, il secondo barone più potente del regno e cognato del re. Il 7 luglio 1460 le forze riunite del principe di Taranto e del pretendente angioino sconfiggono le truppe di Ferrante alla foce del Sarno, ma il 18 agosto 1463 con la battaglia di Troia i legittimisti aragonesi, con l’aiuto determinante dell’eroe albanese Giorgio Castriota Scanderbeg, mettono definitivamente in rotta le forze confederate ribelli. Il 21 settembre 1463 Giovanni Antonio, con il preciso obiettivo di conservare cariche, privilegi e domini, chiede ed ottiene di riconciliarsi con il re a patto di privare del suo sostegno il pretendente Giovanni, tornato in Provenza. A tal proposito va notato che questa tendenza a giocare la partita su più di un tavolo coinvolgeva un po’ tutti i personaggi interessati, re compreso, all’epoca della I congiura dei baroni ed avrebbe raggiunto l’acme all’epoca della II congiura dei baroni. Morte di Giovanni Antonio de Balzo Orsini: Così scrive il De Simone: “Dopo il ritorno di re Giovanni in Francia, Giovanni Antonio chiese la pace e mentre si trovava in Altamura gli furono inviati Antonello Petrucci ed il cardinale Rovarella per comporla nel mentre, si disse, nel campo del re si tramava la morte del potente feudatario. Della congiura facevano parte: Paolo Tricarico, Antonio D’Ayello, Antonio Guidano da Galatina, Giacomo Protonobilissimo, Gaspare Petrarolo (il cui congiunto Gabriele era rinchiuso nella Torre del Parco). Giunti in Altamura trovarono il Principe con febbri malariche e così diffidente da minacciarli di morte. Allora il Guidano e l’Ayello, sicuri della ricompensa reale, entrarono di notte nella stanza da letto e lo strangolarono (15 novembre 1463 ). Il partito aragonese sostenne che fosse morto per cause naturali, ma i premi e gli onori che toccarono ai congiurati rivelarono chiaramente le intenzioni del re. Il suo corpo, secondo le disposizioni testamentarie, fu trasportato in Galatina, accompagnato dai vescovi di Otranto, Gallipoli, Castro ed Ugento e tumulato in abito da frate nella chiesa di S. Caterina, sacrario della famiglia”. Dopo la morte provvidenziale di Giovanni Antonio il re, guardandosi bene dal rispettare le volontà testamentarie del defunto e della vedova Anna Colonna, si precipitò a Lecce nel dicembre 1463 ed incamerò nel demanio regio il principato di Taranto, la contea di Lecce e le ricchezze della famiglia (ammontanti ad oltre un milione di ducati) nella qualità di marito di Isabella Chiaromonte e deliberatamente ignorando i diritti di successione spettanti ad Anghilberto del Balzo, marito di Maria Conquesta, figlia illegittima di Giovanni Antonio. E per porre la parola fine a quello che aveva rappresentato “ uno stato dentro lo stato “ re Ferrante disintegrò il sistema di alleanze e parentele del principe. ....................... continua. ......................1 punto
-
Salve a tutti, secondo voi arriva allo SPL pieno questa piastra del 1839. mi farebbero molto piacere le vostre considerazioni. grazie a tutti quelli che vorranno intervenire1 punto
-
1 punto
-
comunque grazie a tutti per la vostra collaborazione. ;) :D :lol: :rolleyes: :P1 punto
-
a mio parere l'assenza dei gigli medicei nel quarto di destra del rovescio non consente di qualificare SPL, anche in assenza di ulteriori notizie sul contorno incuso e sul peso1 punto
-
Provate ad usare un anello a led 6000-6500 k che e' luce nordica con assenza di raggi infrarossi (sono quelli che danno le tonalita' rossicce). A me vengono abastanza bene. Saluti1 punto
-
1 punto
-
La zecca di Lecce al servizio del re Alla zecca di Lecce devono essere attribuiti anche alcuni mezzi carlini (o ‘armellini’) con indicazione della officina monetaria in esergo (LICI) sul rovescio, a nome di Ferdinando I (che istituì l’ordine equestre dell’armellino nel 1463- fig. 14-), Ferdinando II e Federico III d’Aragona [CNI XVIII, p. 279; MEC 14, pp. 377-8, 392, 394, 396]. Dalla Cronaca di Notar Giacomo abbiamo notizie specifiche sugli ‘armellini’ di Federico d’Aragona: «A dì 2 de augusto 1497 de mercoridì fo emanato banno per Joyanna da parte del Signore Regente per ordinacione dela Maesta del Signore Re che le armelline facte in Leze se dovessero pigliare per ciascheuno a grana cinque l’una» [Fusco G.V. 1846]. Dopo il 1497 non si hanno altre notizie sulla zecca. Possiamo dunque così riassumere i NOMINALI EMESSI: a nome di Renato d’Angiò (dopo il 1460) : - in argento, carlino (o gigliato) con croce duplicata di Lorena o doppia croce d’Angiò; - in mistura, denari tornesi (di cui a tutt’oggi non esistono esemplari noti). a nome di Ferdinando I d’Aragona (dopo il 1463): - in argento armellino con rosetta nel campo al rovescio .[CNI XVIII, p. 279, n. 1]. (per dovere di cronaca dobbiamo citare un presunto esemplare unico di coronato dell’angelo con busto di Ferrante al diritto ed Arcangelo Michele al rovescio con sigla LICI in esergo (di stile rozzo); [riportato da:A. D’Andrea e C.Andreani in: Le monete medioevali di Puglia,Media Ed., pag.210] . a nome di Ferdinando II d’Aragona (1495-96): -in argento, armellino con F nel campo al rovescio [CNI XVIII, p. 279, nn. 1-3]. ........................ continua ...............1 punto
-
La zecca di Lecce al servizio del principe Secondo il De Simone (1883), poi ripreso dal Palumbo (1910), la regina Maria d’Enghien, una volta rimasta vedova di re Ladislao, ritornò a Lecce dopo la parentesi napoletana, abitando alternativamente alla Torre di Belloluogo e al palazzo comitale cittadino, provvisto quest’ultimo di ampie sale cosparse di stucchi ed oro. Nel 1435 , dopo che con il consenso del figlio e con atto del notaio Memo di Taranto ebbe venduto lo splendido edificio alla famiglia Guarino, andò probabilmente ad abitare nel più sicuro castello di città, “anche allora ben munito di molte camere e d’una vecchia torre fatta edificare, dicesi, dai Brienne. Si aggiunge che ivi era custodito il gran tesoro di Raimondello e di Giov. Antonio, e vi era situata anche la zecca”. Ma, da un punto di vista strettamente cronologico, la prima notizia sulla presenza di un’officina monetaria nella città di Lecce si deve al letterato leccese Iacopo Antonio Ferrari (1507-1587) che in un passo dell’Apologia paradossica della città di Lecce descrive gli anni del principato di Giovanni Antonio, un “ principe assoluto “ che governa “ tenendo amicizia, ed occulte intelligenze “ con i “ potentati d’Italia “ ….e batte “ in Lecce pubblicamente moneta di oro e di argento “. Successivamente Giulio Cesare Infantino (1581 – 1636), autore della Lecce Sacra fa riferimento ad una residenza extraurbana del principe indicata quale sede di zecca: “Uscendo dalla porta di San Biagio per una dritta e ampia strada” , si scorge un “ dilettevole Parco, oltre una bellissima e famosissima Torre” congiunta ad altri edifici, “fabbriche fatte fare per sua abitazione da Gio. Antonio del Balzo Ursino” ed “ in queste abitazioni facea egli battere pubblicamente moneta d’argento e d’oro, il cui pensiero dette a Gasparo de Argenteris suo molto confidente, il quale fè anche protomastro de’ pesi, e di misure, il qual’ufficio questi d’Argenteris han posseduto fin’a questi ultimi tempi nostri“. Nel 1871 il Maggiulli scriveva però “ L’Infantino che ci ha tramandato questa notizia non spiega se il del Balzo Orsini coniò moneta per propria autorità o per concessione del d’Angiò”. Infatti l’Infantino, pur indicando l’ubicazione e richiamando le competenze direttive della suddetta zecca, non menziona alcun privilegio o concessione regia, relativi al conio di moneta, verosimilmente accordati al principe di Taranto dai sovrani di Napoli. Giuseppe Maria Fusco fu il primo a descrivere e pubblicare, nel 1846, il carlino d’argento di Renato d’Angiò, contrassegnato dalla lettera L sormontata da un giglio “ la quale non altro potette denotare, tranne la iniziale del cognome del maestro di zecca di quell’età”. Di diverso avviso invece fu Giovanni Vincenzo Fusco il quale, prendendo in esame due monete d’argento d’età successiva (una a nome di Ferdinando II , l’altra a nome di Federico III d’Aragona), contrassegnate da LICI nell’esergo, unitamente ai cavalli di rame (coniati a nome di Ferdinando I) con sigla L, attribuì tale iniziale non al cognome di un eventuale maestro di zecca, ma alla città di Lecce (“ LICI”), luogo di provenienza e quindi di conio delle monete. Il Maggiulli (1871), constatata la totale assenza di prove documentarie comprovanti la concessione di un privilegio sovrano, fu indotto a ritenere che fosse stato Renato d’Angiò a concedere “ il privilegio a Lecce di tener zecca, dalla quale uscì quel distinto nummo in argento che si nominò carlino”. Quindi egli fu il primo ad ipotizzare che la lettera L potesse fare riferimento alla zecca di Lecce. Le ragioni storiche che portarono all’inaugurazione della zecca di Lecce si possono ricondurre alla nota data del 7 luglio 1460 quando, come abbiamo già visto, le forze riunite di Giovanni Antonio e di Giovanni di Lorena sconfissero Ferrante alla foce del Sarno. Successivamente a tale evento, per onorare le spese di guerra, ma non del tutto scevro da ambizione personale (nel giugno 1460 l’ambasciatore milanese Da Trezzo scriveva al suo signore : “El re m’ha dicto chel Principe de Taranto se vole fare signore de questo Reame”) il principe di Taranto cominciò a coniare, a nome di re Renato d’Angiò, carlini (o gigliati) con la croce di Lorena o doppia croce d’Angiò, oggi rarissimi, che mostrano al dritto una lettera L sormontata da un giglio angioino. Zecca di Lecce: Carlino del principe di Taranto Giovanni Antonio del Balzo Orsini, a nome di Renato D’Angiò pretendente (1461)................................. continua ....................1 punto
-
Non so dove tu abbia comprato queste monete, ma ragionavo sul fatto che in un'asta, anche piccola, avrebbero faticato non poco ad essere vendute, visti gli evidenti problemi. Da altre parti (piccoli mercatini, tra collezionisti o da piccoli commercianti in zone con poca offerta numismatica) forse è piu' facile vendere questo tipo di monete approfittando della minore offerta e competizione oppure della passione di qualche neofita. La tua passione è sicuramente da incoraggiare, ma ti consiglio di evitare le monete con evidenti problemi di cancro del bronzo e di dare un occhiata alle piccole aste presenti in internet tipo queste: http://www.deamoneta.com/auctions/search/223?c=Impero+Romano http://www.deamoneta.com/auctions/search/231?c=Roman+Imperial http://numismaticakatane.bidinside.com/it/cat/3/1/monete-romane/1/ Dove spesso, anche per 50 euro, si possono comprare ottime monete.1 punto
-
Sì, confermo la leggera rottura di conio, si tratta di un difetto di entità talmente minima che non in genere non influisce sull'importanza numismatica e commerciale del tondello, spesso non viene nemmeno segnalato, anche perchè nella maggior parte delle monete napoletane il difetto di conio è la norma. Se dai un'occhiata alla classificazione delle classi secondo il metodo "Gigante" capirai meglio il concetto. :good:1 punto
-
Forse, oltre che discutere sul risultato raggiunto, vale la pena analizzare il processo logico desguito per approssimarsi al riconoscimento di questo nummo. Premetto che qusto, così come gli altri nummi postati come "bassissimo impero" (o che eventualmente posterò ancora), nonostante la loro bassissima conservazione sono interessanti, in quanto perfettamente contestualizzati: provengono dall'area vandala e circolavano intorno al 500-510, momento nel quale furono ritirati dal parco monetario. Il primo punto logico fu ipotizzare due diversi orientamenti del rovescio: quello che suggeriva una "consecratio", e quello che proponeva la base di una ghirlanda. In entrambi i casi ci si trovava di fronte a una moneta del IV secolo, se non prima, molto tosata per portarla ad un peso che effettivamente corrisponde a quello del nummo a cavallo tra IV e V secolo. L'accostamento alla consecratio non reggeva e quindi ci si è orientati a quella della base di una ghirlanda. A questo punto, orientato correttamente il rovescio, l'unico elemento visibile con relativa certezza erano le due lettere TS in esergo, a destra. Cercando sulle tavole helvetica, risultano essere pochi gli eserghi terminati in TS. Tra di essi, il VOT XX MVLT XXX di Costanzo secondo per Antiochia. Osservando meglio la parte alta del rovescio, fu possibile scorgere le due lettere LT, riconoscibili con abbastanza sicurezza. A questo punto, anche l'esergo può essere rivisitato e in esso, anche se malamente e coincidente con dei grumi, può essere riconosciuta la lettera N prima di TS, e dunque l'esergo terminante in ...NTS. A questo punto l'ipotesi della votiva di Costanzo II per Antiochia cominciava a prendere corpo e apparve utile il confronto tra il nummo proposto e la suddetta votiva, anche se, purtroppo, non abbiamo trovato l'esemplare con esergo terminati in NTS: Il confronto risulta a favore di questa interpretazione, sicché finalmente ricostruzione della lettura del nummo può essere ragionevolmente la seguente: Ovviamente restiamo sempre nel terreno delle ipotesi ragionevoli e non delle identificazioni certe. A voi criticare l'analisi realizzata, che ovviamente è criticabile e sono proprio le obiezioni fondate al ragionamento seguito ciò che ci fanno crescere tutti come numismatici e non come meri aspiratori di monete. Antvwala1 punto
-
Devi fare un pò di esperienza in maniera da acquistare al giusto rapporto qualità prezzo. Pagare un pò più un pezzo quando si comincia a collezionare è normale. Per fare esperienza ci vuole tanto tempo. Ti consiglio di visitare e acquistare da quest'asta. Secondo me per cominciare va benissimo. Puoi prendere qualcosa sia dalla sezione romane che dai lotti multipli. Ti allego link dei PDF e dell'asta http://www.inasta.com/Aste/AN055/PDF/AN055_Lotti_418-1267.pdf http://www.inasta.com/Aste/AN055/PDF/AN055_Lotti_4706-5456.pdf http://www.inasta.com/index.asp?page=11 punto
-
Potrebbe trattarsi di una frazione di follaro,della zecca di Salerno, XII sec.- Ciao Borgho1 punto
-
Sulla posizione del'aquila certo che ci sono differenze, questa è la prima cosa da vedere, poi se è radiato o laureato e corazzato, infine la legenda nel suo sviluppo; es: certe portano in greco traian decio, altre decio traian ect. Sulla Y o V devo dire che McAlee non porta differenze, ma tutte sono con la V, cosa che ho già notato per esempio nella moesia e tracia, probabilmente non determinano sostanzianlmente la legenda. Il McAlee ha una tavola sinottica solo per il Butcher, ma ogni moneta presente ha anche dei riferimenti ad altri libri ed il Prieur è il più citato; es: la numero 116/e corrisponde alla 351 del Prieur.1 punto
-
1 punto
-
Torno alla farmacia Alle due Colonne perchè quando si parla di essa non si può non menzionare anche quella Alla Colonna e mezza. Si deve premettere che tutte le farmacie di Venezia erano differenziate per l’insegna, che doveva essere esposta "per non incorrere nella multa di 5 ducati" e costituiva anche negli atti pubblici il "marchio" distintivo delle varie botteghe. Per questo motivo non era ammesso che due farmacie potessero postare la stessa insegna. Scrivono le cronache: "Racconta la tradizione che a due Spezierie volevasi porre la medesima insegna alle "Due Colonne", e che un Magistrato, per tagliar corto, come non si usa certamente adesso, mandò un Fante a tagliare in una di queste farmacie una colonna per metà, per cui ne vennero e sussistono ancora le due insegne: Due Colonne e Una Colonna e Mezza, rispettivamente in Campo S. Canciano e in Campo S. Polo. Dice ancora la leggenda che, ai tempi della dominazione austriaca, venisse imposto di ritirare l'insegna della colonna e mezza che stava appesa sopra la porta della Spezieria perchè serviva di ostacolo al passaggio delle baionette delle truppe che andavano all'esercitazione in Campo di Marte e che in seguito anche gli altri credettero di fare lo stesso. (Fonti: M. Trinchieri di Venanson-A. Schwarz). Insegna dal Codice Gradenigo Insegna effettiva apollonia1 punto
-
Ciao Gaetano, almeno da parte mia novità nessuna; ipotesi nel passato sono state fatte (vedi Sambon, vedi Giliberti BCNN 1951) ma alcune di queste monete sono molto impotanti (come i coronati con la C e quelli con l'Arcangelo con le I, C, V, e anche alcuni ducati) quindi a mio parere queste non bastano......ma le ricerche sono sempre vivee....e speriamo che in futuro si possa assegnare queste sigle ad un nominativo certo.1 punto
-
Questa è la foto della moneta uscita dalla Summer Auction 2013 della Rauch. GRIECHISCHE MÜNZEN - MACEDONIA Könige von Makedonien Philippos III. (323-317) (D) Tetradrachme (17,25g), "Babylon" (Mesopotamia), ca. 323-317 v.Chr. Herakleskopf / Zeus Aëtophoros. Price P205, Müller P117. Im Rv. kleine Stelle leicht berieben. s.sch.-vzgl. Diametro 25-27 mm, peso 17,24 g in perfetto accordo con quello in didascalia. apollonia1 punto
-
ci vedo __LT _NTS se fosse un VOT di costanzo II tagliato e e super ridotto ?1 punto
-
Ci vorrebbe un pò di sano pragmatismo e noi stessi, i privati, siamo ben lungi dal voler sminuire il lavoro degli specializzandi e specializzati in numismatica, che anzi dovrebbero essere assunti in pianta stabile in maggiore numero e contribuire in prima fila alla tutela delle numerose raccolte pubbliche. Un piccolo risultato contro la crisi culturale (che purtroppo ha una scala molto vasta) e contro la disoccupazione giovanile. Si spera solo che, ottenuto il posto stabile, non si rischi di sedersi sopra oppure di essere utilizzati in maniera impropria (per tutt'altre faccende….). Quello che non va bene è l'assenza di dialogo tra i "laureati accademici" e i "privati". Ci sono esperienze diverse ed esistono comunque dei privati che hanno buone conoscenze in determinati settori e dobbiamo auspicare un sano e proficuo travaso delle rispettive conoscenze. In tutti gli altri paesi è normale questo spirito di collaborazione e a Parigi agiscono dei teams che lavorano specificatamente sulle monete celtiche, dove collaborano insieme laureati specializzati e privati appassionati di questa disciplina e che hanno maturato utili conoscenze. E' il solito principio della meritocrazia, che notoriamente ha attecchito molto poco qui in Italia. Chi sa deve dare il suo contributo. Non si tratta di una banale ovvietà, in quanto è proprio un sereno dialogo tra i privati e i vari laureati sia di carriera universitaria sia ministeriale (comprendendo anche le Soprintendenze) che può agevolare anche la ricerca per una equilibrata normativa che possa tutelare i vari diritti (incluso anche quello del collezionismo privato). Se cominciamo subito col guardare in cagnesco i privati che collaborano (a titolo gratuito, se non talvolta a spese proprie) con l'intima preoccupazione che un simile lavoro possa togliere potenziali posti ai laureati disoccupati, non potremo mai progredire verso una migliore cultura.1 punto
-
Giusto, ho avuto un lapsus... :D Sent from my Quechua Phone 5 using Lamoneta.it Forum mobile app1 punto
-
1 punto
-
1 punto
-
I dipendenti della zecca in quanto svolgono un lavoro particolare hanno le impronte digitali registrate. Se le fate vedere alla polizia possono risalire al colpevole del misfatto 8-)1 punto
-
Alessandro, ma hai voglia ad arrivare a 10mila pezzi con le restrizioni imposte alla soglia dei 5mila. Per il resto, beh mi riguarda poco, perché già solo per arrivare a 5mila devo farne di strada. Penso però che quello che io considero un gioco, perderebbe il suo appeal con queste restrizioni... ;-)1 punto
-
Ciao, si tratta di uno zecchino in oro emesso durante la Sede Vacante 1740 a Roma, classificabile come Muntoni 4. A giudicare dalle foto pare autentico, la debolezza che si rileva sullo stemma è comune ad esemplari di questa tipologia così come l'escrescenza di metallo sull'ala destra della colomba, nel tuo caso poco marcata, dovuta ad una frattura di conio che nei tondelli coniati successivamente è assai più evidente. Ciao, RCAMIL.1 punto
-
Secondo quanto scrive il Bovi, il PR ed il MIR la sigla Y è da attribuirsi a Giovanni Miroballo padre di Antonio (sigla A oppure M) quindi la Y verrebbe prima della M................ma secondo Voi è vero ? @@francesco77..1 punto
-
1 punto
-
ciao, per me complessivamente è un BB,meglio il rovescio sicuramente. il dritto per me denota un'usura evidente ma comunque la patina le da una certa particolarità. complimenti per l'acquisto :) marco1 punto
-
Non vedo le 8 stellette per esempio, che sono di norma agli angoli della cornice al diritto, interessante.....1 punto
-
1 punto
-
Ciao Amedeo, avevo notato anch'io ma a dire il vero non avevo notato che non avevi puntualizzato il nome del re. Pensavo volessi sapere la differenza tra il conio dei saluti di Carlo I e Carlo II, grazie mille a Lorenzo per la precisazione, visto che ci siamo desidero scrivere un mio pensiero: in generale, i saluti di Carlo I hanno uno stile più fine rispetto a quelli del suo successore, i rilievi sono leggermente più bassi e le figure hanno delle espressioni meglio definite e più realistiche, in sostanza cambia l'impronta dei conii perchè i rilievi sono più marcati in Carlo II. Ovviamente siamo nella seconda metà del XIII secolo, difficile trovare esemplari perfettamente uguali se non dello stesso conio. Non dimentichiamo che ogni conio era frutto della mano e dell'originalità di un artista e non di macchinari. ;)1 punto
-
Stasera potrò prendere visione del tetra Price P205 illustrato al post #1812 con il volto di Elio di fronte come simbolo sul rovescio. Come premessa, qualche notizia sul dio del Sole. ELIO: nella mitologia greca era la personificazione del Sole, come corpo celeste e datore di luce, più tardi confuso con Apollo; era figlio del titano Iperione (la più antica personificazione del Sole) e di Teia, fratello di Selene (la Luna) e di Eos (l'Aurora). Nel mito fu il dio "che cammina al disopra" di tutte le cose. Risvegliato dal canto del gallo, che gli è sacro, e preceduto dall'Aurora, egli guida ogni giorno la sua quadriga attraverso la volta celeste, dallo splendido palazzo che sorge a oriente, nella Colchide, fino a un palazzo egualmente splendido nell'estremo occidente, dove scioglie i cavalli e li lascia pascolare nelle Isole dei Beati. Poi torna a oriente percorrendo il fiume Oceano che scorre attorno al mondo, carica cocchio e cavalli su una nave dorata costruita da Efesto e dorme tutta la notte in una comoda cabina. Una sola volta Elio mutò il suo corso, allorché Atreo, su consiglio di Zeus, propose al fratello Tieste di cedergli il trono di Micene, posto che il sole muti il suo corso. Tieste acconsentì ad abdicare se un simile prodigio si fosse verificato. Al che Zeus sovvertì le leggi della natura, ed Elio, giunto a metà del suo viaggio nel cielo, fermò il cocchio e voltò i cavalli verso l'alba e quella sera, per la prima e per l'ultima volta, il sole tramontò a oriente. Così Atreo regnò definitivamente sulla città. Dall'immagine primitiva con la quale si paragonò il Sole a una ruota fiammeggiante che si volge per il cielo, si passò ben presto a quella del carro che percorre il cielo, tirato da focosi cavalli splendidi, lucenti, spiranti fuoco, e chiamati Piroide, Eoo, Etone e Flegone. Omero non sa nulla ancora del cocchio né dei destrieri infuocati. Elio ebbe come moglie Perseide, una delle figlie di Oceano e di Teti, da cui nacquero vari figli: la maga Circe, Eete, che regnò nella Colchide, dove Elio aveva il suo aureo palazzo, e Pasifae, che fu moglie di Minosse, e un figlio, Perse, il quale spodestò il fratello Eete, e fu ucciso dalla propria nipote, Medea. Inoltre, Elio si unì a varie altre donne: la ninfa Rodo, dalla quale ebbe sette figli, gli Eliadi; Climene, una delle sorelle di sua moglie Perseide, la quale gli diede Fetonte e cinque figlie, anch'esse chiamate le Eliadi; Leucotoe, figlia d'Orcamo e d'Eurinome. Figli di Elio erano considerati Augia, che fu re dell'Elide, e soprattutto Fetonte ("il brillante"), che presso Omero è solo un attributo del dio e più tardi divenne persona. Nel mito di Fetonte, ampiamente esposto da Ovidio (Metamorfosi, I, II), Elio cedette alle insistenze del suo figliolo che da tempo gli chiedeva di poter guidare il cocchio del Sole. Fetonte voleva dar prova della sua abilità alle sorelle; e sua madre Climene lo incoraggiò all'impresa. Ma poiché gli mancava la forza necessaria per controllare lo slancio dei bianchi cavalli che le sue sorelle avevano aggiogato al carro, si lasciò trascinare dapprima così alto nel cielo che tutti i mortali rabbrividivano per il freddo, e poi così vicino alla terra da inaridire i campi. Zeus, in un impeto di collera, lo annientò con la folgore e Fetonte precipitò nell'Eridano (Po). Nel mito, Elio si presenta anche come pastore. Infatti nell'isola di Trinacria, poi identificata con la Sicilia, aveva sette mandrie di giovenche e sette greggi di pecore, ciascuna formata da cinquanta capi, il cui numero non aumentava né diminuiva mai, custodite da due ninfe Fetusa, ("la splendente"), e Lampezia, ("la brillante"), figlie di Elio e di Neera. Si spiegò questo armento come l'immagine dell'anno primitivo di trecentocinquanta giorni e altrettante notti, divisi in cinquanta settimane. Altri ritenne che l'armento bianco-rosato del Sole fosse l'immagine delle nuvole che accompagnano il Sole quando sorge e quando tramonta. Più tardi Elio fu identificato con Apollo, che pure ci è presentato come pastore. Elio tutto vede e dappertutto penetra, ma non è un acuto osservatore e non si accorse nemmeno che i compagni di Odisseo rubavano il bestiame a lui sacro. Questi buoi del Sole, che furono mangiati dai compagni di Odisseo, erano animali d'un candore immacolato, dalle corna dorate, ed erano custodite dalle figlie del Sole, le Eliadi. Anche il gigante Alcioneo rubò due volte i sacri bovini di Elio, da Erizia e dalla cittadella di Corinto. Gli Argonauti, invece, veleggiando lungo le coste orientali della Sicilia, videro i bianchi greggi di Elio pascolare presso la riva, ma resistettero alla tentazione di rubare qualche capo. Eracle, mentre attraversava il deserto africano, incoccò una freccia nell'arco e la scagliò contro Elio, perché non riusciva a lavorare con tale calura. Si scusò poi col dio e subito allentò l'arco. Per non essere da meno in fatto di cortesia, Elio imprestò a Eracle la sua nave d'oro, perché in essa navigasse per raggiungere le mandrie di Gerione nell'isola di Erizia. Rodi è il suo dominio. Accadde che, mentre Zeus assegnava isole e città ai vari dèi, si scordasse di Elio. Accertatosi della sua dimenticanza, pensò di ricominciare tutto daccapo; ma Elio, con cortesia, gli disse che si sarebbe accontentato dell'isola di Rodi appena emersa dal mare, e ne prese possesso. Colà generò nella ninfa Rodo sette figli e una figlia, Elettriona, che morì vergine e fu onorata come semidea. Zeus aggiunse ai possedimenti di Elio anche l'isola di Sicilia, che fu scagliata in mare durante la battaglia con i Giganti. Quando Poseidone vantò pretese su Corinto, la città di Elio, ottenne soltanto l'Istmo, mentre Elio fu ricompensato con l'acropoli della città. Egli è concepito come rivelatore e punitore delle colpe degli uomini e degli dèi, e perciò si usa invocarlo con Zeus nei giuramenti e nelle testimonianze. Omero racconta che Elio informò Efesto del convegno amoroso di Ares con Afrodite, e questa, per vendicarsi dell'azione delatoria del dio, aveva ispirato a tutti i figli di Elio amori abominevoli (esempio tipico quello di Pasifae per il toro). nell'inno omerico a Demetra Elio rivela alla dea da chi e come le fu rapita la figlia Persefone; più tardi per opera degli Orfici Elio divenne la fonte della sapienza e il dispensatore della prosperità e di ogni vita. Elio da Euripide in poi fu tenuto lo stesso che Apollo, cioè il dio onniveggente della vaticinazione: dal che derivò anche il soprannome di Febo. Il dio Sole ebbe il suo culto nell'isola di Rodi, dove in suo onore si celebravano annualmente grandi feste di cui facevano parte gare ginniche e musicali. A Rodi, all'ingresso del porto, s'innalzava il "Colosso di Rodi", una statua colossale di bronzo di Elio, una delle sette meraviglie del mondo. Gli erano sacri il gallo, il nunzio del giorno, gli animali di colore bianco e rosso, e in specie il cavallo. Elio fu nume supremo a Corinto; il suo culto, considerato da alcuni di origine eolica, decadde in seguito all'immigrazione dorica. Ebbe culto anche nell'Elide, ad Argo. A Roma si trovano tracce di un culto del dio Sole: era certo venerato presso i Sabini. L'antico santuario di Sol a Roma sul Quirinale era attiguo al tempio di Quirino, divinità di origine sabina. Augusto consacrò al dio Sol il 9 di agosto, giorno della battaglia di Farsalo. Nel circo gli era sacro l'obelisco, e vi aveva un tempio; era pure il protettore dei giochi del circo e dello spazio loro riservato, come guidatore della quadriga del cielo. apollonia1 punto
-
Ho riunito e introdotto in questa sede l'interessante argomento in quanto avevo previsto che, al solito, si sarebbero accesi gli animi su una materia niente affatto secondaria. Non stiamo parlando di figure che sono preposte, come giustamente evidenziato da Polemarco (col codice alla mano), alla tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione di beni culturali (e quindi anche delle monete). E' ovvio che ci vogliono figure riconoscibili sul piano professionale e con titoli legali, in quanto esistono anche delle oggettive responsabilità. Ma qui stiamo parlando di contributi culturali che, se mi permettete, è cosa un pò diversa e complessa. Da persona concreta (almeno lo ritengo), avevo subito tirato fuori un esempio pratico, come quello del Museo Nazionale Romano che ha avviato una collaborazione con cultori privati di provata esperienza (con pubblicazioni alle spalle, accolte anche in ambienti accademici). Magari, e lo auspico, che ci siano anche numismatici con adeguati titoli di laurea in grado di fornire un valido aiuto nei vari settori specialistici. Basta cercarli…. Veramente è stata MAP, una archeologa con interessi in numismatica, a balenare la possibilità di denunce….. e su quali basi? Per esercizio abusivo della professione, come un falso medico? Ma non fatemi ridere…. Qui c'è una professionista, con adeguati titoli di laurea, che è la responsabile del medagliere del museo romano. E' lei che si assume la responsabilità della tutela e fruizione di monete, in quasto caso della zecca di Milano. Chiaramente e in prima battuta potrebbe rivolgersi ad altri archeologi/numismatici per la catalogazione. Ma se individua altre persone, al di fuori dello specifico percorso universitario, che hanno dato dimostrazione di possedere competenze e che non vengono neppure pagate per il competente aiuto, sinceramente non vedo dove sta il "reato". Una cosa è collaborare a studi numismatici a fini di lucro (allora diventa una sorta di esercizio abusivo di professione), altra cosa è contribuire in via gratuita alla crescita culturale. Allora dove la mettiamo con la famosa meritocrazia? Solo chi sa dovrebbe vedere premiata la sua conoscenza. Nella storia della numismatica ci sono tanti esempi di illustri numismatici, che hanno dedicato anni e anni a seri studi per sincera passione, fino ad avere riconoscimenti di alto prestigio, anche se per lo più onorari. All'estero è prassi comune, senza scomodare il caso limite di Max van Bahrfeldt, che era un generale dell'esercito prussiano, criminale di guerra (I guerra mondiale), condannato a morte nel 1925 da un tribunale del Belgio, ma che in Germania divenne docente onorario in numismatica, all'Università di Halle, con studi che ancora adesso sono consultati (migliore destino umano ebbe il grande Ulrich Bansa, di lontane origini danesi, anche lui proveniente dall'ambiente militare, ma in Italia). Lasciamo stare lo spettro delle denunce. Qui si tratta semplicemente di riconoscere le giuste competenze, con giusti titoli per i giusti riconoscimenti di responsabilità legale, ma ritengo che sia sempre possibile aprirsi a un fecondo dialogo anche con altri cultori, proveniente da ambienti privati. Altrimenti saremo fatalmente destinati a un chiuso corporativismo, autoreferenziale, cosa particolarmente perniciosa in una situazione che vede coinvolti seri e preparati collezionisti italiani (allora dovrebbero rimanere zitti !?).1 punto
-
Grazie @@Arciduca , ho preso esempio da te per inserire il nome nelle foto. IMG_5731.jpg GRAZIE @@vaio4ever! Non hai idea di quanto piacere tu mi abbia fatto con questo post! Potrà sembrare banale, ma vedere che qualcuno abbia apprezzato la mia idea così da utilizzarla anche per sè è una grandissima soddisfazione. Perchè un forum, per come lo concepisco io e per non saper nè leggere nè scrivere, è anche un luogo dove si condivide, si collabora, ci si diverte e si può mettere qualcosa di proprio, anche se piccolo, a disposizione degli altri. La stampa dello sfondo io l'ho fatta su carta a quadretti, così si possono anche sempre vedere le misure ( in caso di foto di monete al di fuori dell'Euro) e poi l'ho incollata su cartoncino rigido, così da evitare lo stropicciamento della carta. :good:1 punto
-
La mia piccola collezione del regno la regalero' a qualcuno del forum che mi sta' simpatico.1 punto
-
Ciao. "Un maresciallo ha alzato gli occhi al cielo e ha subito premesso che, trattandosi di un bene mobile, non c'era intanto l'obbligo di farlo rientrare nell'asse ereditario, a meno che non ci sia una espressa decisione da parte degli eredi (anche perché ha dei costi). Si è chiesto se la collezione fosse stata comunicata alla Soprintendenza. In caso negativo lui ha consigliato vivamente che chi eredita monete e reperti archeologici debba esercitare tale comunicazione, anche perché"cristallizza" (parole sue) in modo definitivo e completo la collezione stessa" Non c'è nessun obbligo giuridico di segnalare alla Soprintendenza il possesso delle proprie monete, salvo che non siano monete di importanza straordinaria (cioè "Beni Culturali", ai sensi dell'art. 10 del "Codice Urbani"); d'altronde, come ci ha ricordato Cliff postando il famoso documento della Soprintendenza di Torino, è la stessa Soprintendenza che ce lo mette per iscritto. Il suggerimento del Maresciallo è dunque un suggerimento giuridicamente non corretto, anche se, nella "Repubblica delle Banane", potrebbe divenire un'iniziativa di buon senso (ma non è detto neppure questo, ve lo assicuro!). E un pò come dire: annotatevi d'abitudine tutti i numeri di targa dei veicoli che transitano davanti a casa vostra; in caso di furto nel vostro appartamento avremo più possibilità di risalire a mezzo che ha trasportato i ladri! Non c'è alcun obbligo di farlo.... ma se lo fate potreste averne dei benefici! Come spesso accade, quando ci si trova intorno ad un tavolo, in un clima "rilassato" e con i volti distesi e sorridenti, può persino accadere....... che i Carabinieri si propongano di redigere un ricorso in opposizione all'acquisto coatto esercitato dal Ministero....! In altre circostanze, pur comprensibilmente diverse, può invece capitare che l'atteggiamento sia viceversa decisamente “ostile”, un'ostilità che sembra travalicare il compito d'istituto che in quel momento deve, per carità, essere compiuto e che sembra assomigliare più ad un “accanimento” personale (penso al “caso Bernardo”, sul quale non è ancora opportuno soffermarsi su certi “dettagli”, ma che dimostra in modo eclatante questa mia valutazione). Non dubito neppure, perchè è capitato anche a me, che si possano incontrare persone negli Uffici preposti non solo gentili ed assolutamente disponibili al dialogo e magari anche....alle confidenze, ma pure di amplissime e moderate vedute! Ci sono eccome...e sono anche simpatiche! Sarà che noi italiani "fraternizziamo" solo se ci incontriamo ad un evento conviviale e rimaniamo invece diffidenti ed arroccati nei rispettivi ruoli quando dialoghiamo a distanza o per motivi professionali....sta di fatto che non si è mai dubitato che singole personalità, sopratutto se incontrate "fuori contesto", possano riservare favorevolissime impressioni. Tuttavia il problema qui è, e rimane, la "direttiva ufficiale" che si deve applicare, "l'ordine di servizio" che va osservato, la posizione formale dell'Ente che va rispettata e che spesso fa dire al soggetto, che intimamente, sarebbe anche disposto a condividere il tuo punto di vista, che...."si, avete ragione...ma vaglielo a dire a quelli lassù..." Le singole posizioni di Tizio e Caio, pur interessanti dialetticamente, se minoritarie rspetto all'opinione dominante di quell'Amministrazione, non assurgono neppure a parametro interpretativo ma rivestiranno al più il ruolo di opinioni dissenzienti rispetto all'interpretazione ufficiale fornita ed osservata dall'Ente. Si parla in questi casi, al più, di Funzionari “cani sciolti” o “controcorrente” ma se tali soggetti sono organici ad un'Amministrazione finiscono (e ciò è inevitabile) per trovarsi sempre quanto va bene “in minoranza” e quando va male persino vittime di veri e propri “boicottaggi” interni. Ecco perchè questi soggetti, “a microfoni spenti” sono anche pronti a confessarti il loro vero punto di vista sull'argomento ma, subito dopo, ti dicono anche di essere, proprio a causa delle loro idee, fuori dai “giochi”. Ora, l'intervento del Prof. Arslan è indubbiamente ben diverso da quello dei CC, ma se andate a leggerlo tutto, comprese le note in calce (note che in genere legge solo Domenico....che poi trova infatti la Nota 56....). mi spiace dirlo ma si colgono dei punti che non mi inducono, a differenza di quanto hanno scritto Altri, all'ottimismo: Ed entro nello specifico La nota 1. a pag. 94 del Notiziario: "Eviterei il termine "moneta archeologica", che sembra riferirsi unicamente alla moneta recuperata in scavo, e userei semplicemente il termine "moneta". La moneta infatti è un "bene culturale" che ricade sotto le leggi di tutela se con più di cinquant’anni dall’emissione, nel caso venga giudicata degna di notifica. Quindi la legge riguarda tutte le monete, senza eccezione, anche quelle con significato unicamente storico." La nota è riferita al termine "monete", riportato nella frase d'esordio dell'intervento: "In questa sede, che ci vede finalmente riuniti a discutere sulle possibilità di conciliare le tradizioni numismatiche collezionistiche e mercantili con il rispetto delle leggi relative alla tutela dei Beni Culturali, nella fattispecie delle monete..." Ebbene, dire che "la legge riguarda tutte le monete, senza eccezione, anche quelle con significato unicamente storico", mi pare un'affermazione potenzialmente fuorviante, se non viene debitamente circostanziata. La legge a cui ci si riferisce (il "Codice Urbani", evidentemente) non si applica affatto (parlo delle norme sulla tutela) "a tutte le monete, senza eccezione, anche a quelle con significato unicamente storico", perchè sappiamo tutti benissimo che se introduciamo nel ragionamento il parametro del "significato unicamente storico", avremmo sottomesso alla legge di tutela probabilmente qualunque moneta con più di 50 anni. E questa conclusione è in palese contrasto con le finalità perseguite dal Codce Urbani, che si occupa invece della tutela dei Beni Culturali, che non sono una "categoria dello spirito" ma rappresentano una definizione con precise implicazioni e con dei precisi "paletti" di riferimento. Diversamente opinando , non avrebbe alcun senso precisare, come fa la Legge, di casi specifici nei quali una moneta riveste la culturalità, bastando una formula "di chiusura" che gliel'attribuisca sulla base del suo solo "significato storico", concetto quest'ultimo che lascia ampia ed incensurabile discrezionalità a chi deve esprimersi su di esso. Ha "significato storico", ad esempio, la prima serie repubblicana della lira del 1946?....... Si?......Bene, allora alla stegua di questo parametro dovremo battezzarla "Bene Culturale" .....E le prime monete da 500 lire d'argento per la circolazione, del 1958, hanno un "significato storico"?...Certo che si..........Allora anche quelle sono Beni Culturali..... O vogliamo metterci adesso anche a discutere che cosa si debba intendere per monete che possiede o non possiede un "significato storico"? Già abbiamo difficoltà ad accordarci sui concetti di moneta “rara o di pregio”....adesso vogliamo discutere anche se e quando una moneta abbia un “significato storico”? Come si vede, ancora una volta il termine "bene culturale" mi sembra richiamato in modo pericolosamente atecnico; se ciò è comprensibile nel linguaggio comune o dell'uomo della strada, altrettanto non può dirsi se ad utilizzare tale definizione è un Tecnico nell'àmbito di un consesso di Tecnici. Vogliamo deciderci a considerare "beni culturali numismatici" solo quei beni numismatici che indica il Codice Urbani in base a caratteristiche di rarità o pregio ben precise? Altrimenti persevereremo nei soliti equivoci in base ai quali passa il concetto che bene culturale sia potenzialmente qualunque monete che ha più di 50 anni. Dopodichè, se questo errore è commesso dai “Tecnici”, non possiam lamentarci se poi i CC. sequestrano tutto, perchè non possono essere i CC. a stabilire il “significato storico” di una moneta e, nel dubbio, dovranno assicurarla affinchè chi di dovere la valuti. Nota 2: "In base alla deroga dal dettato della legge, come è stato osservato, che specifica come tutti i beni culturali conservati sotto la superficie del suolo siano di proprietà dello Stato e conseguentemente quindi vengono definibili come "archeologici". A mio avviso in questa formulazione è la premessa della definizione di "Moneta archeologica", intesa come proveniente da scavo, da distinguere dalle altre monete più recenti (penso in base all’arbitraria soglia del 476 che dovrebbe separare il mondo classico da quello medievale, che tanti danni ha operato nella nostra storia culturale), che quindi non sarebbero "archeologiche", da considerare quindi come un quadro o un mobile d’antiquariato. Cosa che sappiamo non vera, perché la moneta medievale, moderna e contemporanea è costantemente presente negli strati archeologici ed è fondamentale per la loro lettura." La nota 2 si riferisce all'affermazione che il bene numismatico in possesso del privato può ben essere di provenienza legittima...(e ci mancherebbe altro!, direbbe qualcuno....) A parte il fatto che già sentire che vi sia il bisogno di precisare che il privato può legittimamente essere proprietario di una moneta antica mi mette “i brividi”, ancora una volta, mi sia consentito dirlo, si perde di vista il punto fondamentale del problema, che non è l'assunto che le monete "archeologiche" sarebbero solo quelle ante 476, mentre quelle successive sarebbero monete antiquarie. Tale assunto, intanto, non mi sembra sia mai stato sostenuto da alcuno in quei termini; le monete archeologiche sono tutte (e solo) quelle, a prescindere dall'epoca, che sono riconducibili al contesto di giacitura perchè riferibili ad esso. In tutti gli altri casi, qualunque moneta di qualunque epoca non potrà mai dirsi "archeologica", perchè non più riferibile al contesto stratrigrafico di provenienza. Se la moneta non può definirsi, per le ragioni anzidette, "archeologica", cosa mai sarà? La famosa “commissione Panvini” e la conseguente ipotesi di lavoro formulata dal Dott. Bernardi (anche su questo Forum, alcuni anni or sono), la definisce “moneta antiquaria”. Mi pare che questa conclusione sia, a rigor di logica (e non a rigor di intime convinzioni ideologiche, che, se permettete, non dovrebbero trovare spazio in un dibattito come questo) sia difficilmente smentibile (e se lo fosse, mi si dica, per favore, in che modo e con quali argomenti...). Precisato ciò, il fatto che, come riporta la parte finale della nota 2 "...la moneta medievale, moderna e contemporanea è costantemente presente negli strati archeologici ed è fondamentale per la loro lettura" è un'affermazione pienamente condivisibile....ma solo se effettivamente la moneta è stata rinvenuta negli strati archeologici;(particolare che però il Prof. Arslan omette di precisare). Altrimenti, se la moneta, di qualunque epoca e tipologia, non è rinvenuta negli strati archeologici, ma in un album, in una valigetta o in un bidone della spazzatura, essa, caro Professore, non potrà dire un bel nulla in ordine alla lettura di uno strato archeologico che non esiste più e che non è più neppure rintracciabile. Se poi invece, non per finalità di scienza ma per pure ragioni di polizia, considerato che non si riesce mai o quasi mai a trovare o a bloccare la moneta prima che sia fuori dal suo sito, con una fictio archeologica del tutto inutile ai fini scientifici e documentari, si vuole comunque colpire il possessore di quella moneta, anche ove non vi sia alcuna prova che egli sia proprio colui che un anno, 10 anni, 50 anni prima (o chissà quando....) si assunse la grave responsabilità di contestualizzarla dal sito di giacitura, allora lo si dica chiaramente, ma non si ammanti un'operazione di pura repressione poliziesca, che fra l'altro, come sappiamo si conclude spesso in fuffa, con il velo (anzi...con il burka talebano) dell' "archeologia", perchè di archeologico (nel senso comunemente inteso dagli Archeologi e condiviso, mi pare, anche dal Prof. Arslan), in quella moneta così reperita e sequestrata, non vi è più nulla. Eliminata la motivazione archeologica, qual'è, allora, la finalità per cui lo Stato vuole forsennatamente recuperare monete di poco o nessun valore, prive di qualunque valenza o interesse storico e numismatico? Il “Salotto” romano o milanese si è posto questa domanda? Solo per una funzione "recuperatoria" fine a se stessa, di materiale di nessun interesse? Che non sarà mai esposto né catalogato (e forse neppure inventariato)? Ha senso tale funzione nel rapporto costi/benefici e nel più generale "interesse pubblico"? Sarà forse perchè queste monete, in un qualche momento anteriore al loro sequestro (momento che però i "reclamanti" non sanno e non sapranno mai indicare), si presume siano state, forse, giacenti nel sottosuolo nazionale o nel fondale marino e dunque appartengono allo Stato? Sono queste le risposte che ci farebbe piacere ascoltare ma che, naturalmente, dubito che sentiremo mai a “microfoni aperti” . Saluti (e scusate per la lunghezza dell'intervento). M.1 punto
-
Se non ci sono cose nascoste siamo sul qfdc basta guardare il bordo tagliente, il seno sx con panneggio continuo, i visi, la capigliatura della donna e l'elmo dell'uomo, molto molto bella ;) c'è da capire di che colore sia...1 punto
Questa classifica è impostata su Roma/GMT+01:00
Lamoneta.it
La più grande comunità online di numismatica e monete. Studiosi, collezionisti e semplici appassionati si scambiano informazioni e consigli sul fantastico mondo della numismatica.
Il network
Hai bisogno di aiuto?







.thumb.jpg.49bf7893ab8deb0b9efbfc02c41b7421.jpg)